|
Con
Ascarelli il Napoli dall'età del bronzo al Rinascimento
di Giuseppe Pacileo

Dal lontano passato del calcio
napoletano emerge una figura che ogni appassionato della
maglia azzurra deve considerare indimenticabile: Giorgio
Ascarelli. Egli non può essere altrimenti definito che
un mito. Infatti, sa di mito, quel nome, molto più che
non altri ancora più lontani nel tempo – i Potts, i
Salsi eccetera – per la dimensione e la compiutezza
realizzata a pro del calcio napoletano in periodi di
stupefacente brevità; per le intuizioni sue, come dire?
leonardesche; per quell’essere sorto e tramontato, come
dirigente ma pure in panni d’industriale, nell’arco di
un quinquennio (tramontato, tra l’altro, prematuramente
eppure già al vertice dell’intensa ed eccezionale
attività – e i primi paragoni che mi saltano in mente
arrivano da tutt’altro campo. Dico Mozart e dico
Schubert, come prima accennavo a Leonardo, senza il
pudore del “si licet parvis componere magna” perché
ciascuno nel suo campo – angusto oppur sconfinato che
sia – può essere piccino oppure immenso) Mitico, infine,
l’Ascarelli, per quella sorta d’aureola del martirio che
gli regalarono, sebbene postuma, l’anormalità idiota
delle leggi razziali e la normalità ignobile dell’umana
ingratitudine.
Quale il debito del calcio napoletano verso Ascarelli? Più
presto detto che fatto:
a) il rilancio regionale durante la gestione dell’Internaples
ultima versione ;
b) la fondazione della prima A.C. Napoli;
c) il lancio sulla ribalta nazionale della prima squadra
recante il nome della sua città, con un quinto posto,
dopo anni di mortificazioni (quinto posto che grazie
anche alla sua opera diventò terzo e poi quarto posto
dopo la sua morte ) ;
d) i primi due veri e moderni allenatori, Carcano &
Garbutt;
e) il ricorso, indispensabile, a calciatori
professionisti di fatto da affiancare alle pochissime
autentiche forze indigene (o quasi);
f) la concezione stessa del club calcistico in forma e
organizzazione d’Azienda, con tanto di bilancio e con
tanto di stadio proprio (il primo e l’ultimo che il
Napoli abbia posseduto).
Forse mi sono scordato di qualcosa, però ho la vaga
sensazione che di più non si potesse pretendere,
soprattutto in considerazione delle circostanze
ambientali ed epocali.
Fu come passare per magico tocco di bacchetta dall’età del
bronzo al Rinascimento. Con l’Achille Lauro prima
edizione si sarebbe ripiombati nel Medioevo, con quello
della seconda si sarebbe saltati al più dispotico dei
governi borbonici. Roberto Fiore avrebbe inaugurato
l’era moderna. Corrado Ferlaino, dopo un folle decennio
di tipo edoardiano tra miserie e fulgori, è approdato al
computer. Il personaggio magari antipatico a molti è
comunque il primo presidente col quale il Napoli è
arrivato allo scudetto e alla Coppa Uefa, e i fatti sono
fatti. Quattro,
insomma, le presidenze significative, quattro nomi da
incidere sulla pietra. Giorgio Ascarelli, però, fu la
stele di Rosetta (che non è una mia cugina, come qualche
lettore potrebbe supporre, bensì la cittaduzza egiziana
– in arabo Rascidt – ove le truppe napoleoniche
rinvennero nel 1799 una lastra di pietra recante la
“chiave” per interpretare i geroglifici).
Certo, il Nord vantava pure nel calcio i vantaggi d’una
partenza avvenuta molto prima e molto meglio; tuttavia,
fu altamente significativo che, nel ristretto gruppo più
o meno concorrente della Juve dai cinque scudetti, si
trovasse anche il Napoli, quello immatricolato e targato
da Ascarelli pur se guidarlo toccò a Willy Garbutt e
all’ing. Vincenzo Savarese; costui non indegno
successore, laddove nella pletora de’ predecessori –
dilettanti inetti e talvolta gonfi di boria – mi sento
di salvare il solo Emilio Reale.
Di cospicua famiglia ebrea, Giorgio Ascarelli nacque il 18 maggio
1894 al Pendino, quartiere popolare e centralissimo di
Napoli; era dunque “verace”. Rotondetto e di belle
fattezze, la fronte resa ancora più ampia da precoce
calvizie, era ricco di quattrini che amministrò con la
parsimonia dell’avaro intelligente – di quelli che, se
lo ritengono funzionale o gratificante, sono pronti a
spendere anche grosse somme – ed era ricco di quella
sensibile, “artistica” intelligenza che non di rado
esalta la sua razza fino a regalare all’Umanità un
Einstein, un Ojstrakh, un Kafka; piaccia oppur no
all’arianesimo degli Alfred Rosenberg e conseguenti
Adolfi carnefici.
Dunque, mecenate anche dell’arti e studioso di pittura; nel suo
stile schivo, a suo modo anche uomo di mondo. Fu tra i
fondatori del Circolo Canottieri Italia. Industriale del
tessuto, con un fatturato considerevole, la sua
Manifattura di Villadosia allungava propaggini fino in
Lombardia, a Busto Arsizio.
Volle che lo stadio da lui costruito al Rione Luzzatti prendesse il
nome di “Vesuvio”. Lo inaugurarono il 23 di febbraio
1930 ed egli non s’intruppò tra le “autorità”; preferì
mescolarsi alla folla e invano lo cercarono. Tra la
folla assistè al pareggio tra Napoli e Juve, soffrì ai
gol di Munerati e d’Orsi, esultò alla doppietta
riparatrice di Buscaglia. Diciassette (!) giorni e
sarebbe morto, all’alba, di peritonite perforante nella
sua residenza in Villa Bice, al civico 169 di Via
Posillipo. Evento così repentino, inatteso, che Napoli
mistica e insieme superstiziosa lo considerò come
“assunto in cielo”.
Il 13 di marzo, giorno dei funerali successivo alla scomparsa, la
folla sul percorso (Via Caracciolo, Piazza Vittoria, San
Ferdinando, Corso Umberto fino al cimitero ebraico) era
talmente fitta che “in più punti venne sospeso il
traffico” de’ vicoli, narrano le cronache dell’epoca. E
della domenica successiva registrano che a Milano, dove
gli azzurri pareggiarono due a due con i rossoneri
rimontando con Vojak un doppio svantaggio, al 5’
l’arbitro Ciamberlini fermò il giuoco. “Giocatori e
pubblico scattano in piedi e rimangono per un minuto in
silenzio rendendo omaggio alla memoria di Giorgio
Ascarelli”. Si consideri che la squadra, già in ritiro
al nord in quel di Arona, si era sobbarcata al faticoso
viaggio di andata e ritorno in ferrovia (seconda
classe!) per partecipare ai funerali e quindi ritornare
a Milano, arrivo alle 11 della domenica mattina.
Chissà perché dopo e non prima della partita, “ ai giuocatori
è stato comunicato un telegramma di ringraziamento della
signora Ascarelli, commossa dell’omaggio reso dai
giuocatori al compianto consorte ed un altro della
società esortante i giuocatori ad onorare
degnamente sul campo la memoria dell’indimenticabile ed
amato presidente”.
La prosa dell’epoca di già radeva al suolo la regola
dell’accento tonico: i giuocatori però non
avevano avuto bisogno di esortazioni per onorare sul
campo – col giuoco e non col gioco – l’amato
presidente. Quanto all’indimenticabilità, sarebbe
interessante che qualche Sindaco e qualche dirigente
dell’epoca spiegasse come mai nel dopoguerra lo stadio
del Vomero venne intitolato a una disonorevole
“liberazione” e perché tanti anni dopo si preferì per il
nuovo stadio di Fuorigrotta il nome di San Paolo. Non
risulta che l’Apostolo abbia mai accennato al giuoco del
calcio nelle sue “lettere” ai Corinzi o ad altri…
Ancora ancora era stato comprensibile, a metà degli Anni Trenta e
con l’aria che tirava, che il “Vesuvio” ribattezzato
“Ascarelli” dopo la morte del costruttore, diventasse
“Partenopeo”. Ma una volta “liberati”…
A proposito: chissà che con la sua “vista lunga” don Giorgio non
avesse intuito l’imminenza delle leggi razziali. Se
così fu, egli riuscì ad anticipare pure quelle, seppure
al prezzo più alto…
Giuseppe Pacileo
Nella foto, il Presidente Giorgio Ascarelli con
l'idolo azzurro degli Anni Trenta, Attila Sallustro
Il Comandante, un “presidente a mezzadria”

Fu il più classico
esempio, forse l’unico così…preistorico, di “presidente
a mezzadria”. Non nel senso letterale e sostanziale di
spartizione del raccolto a metà, tra il padrone della
terra e il contadino che la lavorava, ma nel senso di
affidamento temporaneo del proprio bene senza perdere il
diritto a comandare. Sua era la proprietà del Calcio
Napoli, sua la maggioranza del capitale, ma ad altri
veniva affidata la responsabilità della gestione della
Società. Parliamo di Achille Lauro, l’inossidabile,
intramontabile presidente del Napoli. Resse, infatti,
direttamente la presidenza del sodalizio azzurro, nella
prima fase del suo impegno, per cinque anni, dal 1936 al
1940, poi, col suo grande ritorno postbellico, restò
sulla massima poltrona della Società per altri tre anni,
dal 1952 al 1954, preferendo poi diventare “onorario”
dal 1954 al 1969. In pratica, quindi, don Achille gestì
in prima persona il Napoli solo per otto stagioni nei
trentatrè anni della sua “presenza” in azzurro. Ma
sempre, sia da presidente effettivo che da presidente
onorario (nominato onorario proprio perché possessore
della maggioranza delle azioni) Lauro fu sempre lui il
“grande capo”, l’uomo delle decisioni, il protagonista
del bello e del cattivo tempo, delle frequenti crisi e
dei successivi auspicati rilanci. In totale, quindi, 33
anni alla guida della Società azzurra, a volte sul
proscenio e più spesso dietro le quinte, quasi quanto le
stagioni totalizzate da Corrado Ferlaino, l’enigmatico
presidente – anche lui a fasi alterne ma più continuo
rispetto al Comandante – al quale nel 1969, a 82 anni
suonati, Lauro si decise finalmente a cedere in maniera
rocambolesca e definitiva la Società.
Achille Lauro, considerato uno dei “presidenti indimenticabili”, in
verità, non lasciò una traccia particolarmente
prestigiosa nella storia del Napoli, a livello di
risultati, ma – come abbiamo detto - operò nell’orbita
azzurra, per oltre trent’anni, con il suo classico
atteggiamento taumaturgico, con i suoi storici giri di
campo col fazzoletto sventolante verso la folla. Fu
criticato, osannato, invocato, nel bene e nel male, tra
apparizioni salva-crisi, studiate eclissi e presenze di
comodo, in una città che nella storia è stata sempre
poco propensa a grandi investimenti nel calcio e che ha
sempre stentato a trovare mecenati, o presunti tali.
(Nella foto, un giovane Achille Lauro)
DON
ACHILLE SUBITO SUL MARE -
L’operosa vita di Lauro si intrecciò quasi interamente,
fin dall’inizio, con la sua attività di armatore e con
quella di pseudo mecenate nel calcio. I suoi termini di
misura passarono - di continuo e con disinvoltura -
dalla “caratura” delle sue navi, in vertiginoso aumento,
alle “azioni” in suo possesso nel Calcio Napoli,
anch’esse lievitate, ma in modo anomalo, finche’ le une
e le altre ( molto funzionali e determinanti nella sua
intensa attività politica, nel periodo di maggior
prestigio) non finirono per abbandonarlo con il
sopraggiungere di una pesantissima crisi economica e
l’inevitabile avanzare degli anni.
Achille Lauro era nato a Piano di Sorrento il 16 Giugno 1887,
quinto di sei figli, tre maschi e tre femmine,
dell'armatore Gioacchino e di Laura Cafiero. Cominciò
presto a disertare la scuola, tanto che, all'età di
tredici anni, suo padre lo imbarco, come mozzo, sul
“Navigatore” . Il primo viaggio di Lauro fu cosi lungo e
terribile che, appena ritornato in Europa dall'America,
il giovane Achille telegrafò disperato al padre
supplicandolo di fargli riprendere gli studi interrotti. Ritornato a Piano di Sorrento, il mozzo ridiventò
studente nell'Istituto navale "Nino Bixio", per uscirne,
al termine di qualche anno, capitano di lungo corso.
Il Comandante, dopo aver ereditato dal padre Gioacchino
l’attività di armatore, arrivò all’età di trent’anni,
alla fine della Prima Guerra Mondiale, con una posizione
di secondo piano di “piccolo armatore”. Ma, una volta
acquisita l’esperienza necessaria per rivaleggiare anche
con spregiudicatezza, cominciò pian piano a prendere il
volo, tanto da arrivare a possedere, nel 1939, allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, una flotta di 57
navi, per oltre 300mila tonnellate, grazie anche alla
sua idea di farsi affiancare nei suoi affari, come
soci, da molti tra gli uomini che lavoravano con lui. A
condizione però che gli lasciassero pieni poteri e fosse
lui solo a comandare. Un “principio” che Lauro impose
anche in altre sue attività collaterali e fornirono
risultati tangibili quando guidò i vari partiti
politici, la società di calcio Napoli, ed il Comune di
Napoli, che amministrò per sei anni.
Sono passati alla storia i s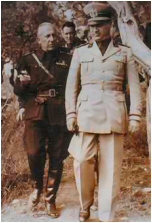 uoi
metodi di procacciarsi i contratti di trasporto,
anticipando la concorrenza degli altri armatori,
lavorando persino la notte a caccia delle richieste via
etere, e addirittura senza possedere nemmeno tutte le
navi necessarie, ma con sotterfugi contrattuali. Il che
gli consentì di ampliare il suo giro di affari e di
praticare costi assolutamente concorrenziali, grazie
alla compartecipazione agli utili dei suoi “dipendenti”. uoi
metodi di procacciarsi i contratti di trasporto,
anticipando la concorrenza degli altri armatori,
lavorando persino la notte a caccia delle richieste via
etere, e addirittura senza possedere nemmeno tutte le
navi necessarie, ma con sotterfugi contrattuali. Il che
gli consentì di ampliare il suo giro di affari e di
praticare costi assolutamente concorrenziali, grazie
alla compartecipazione agli utili dei suoi “dipendenti”.
IL
FASCISMO LO VOLLE PRESIDENTE
- Fino al 1935 l'attività
armatoriale di Lauro si sviluppò senza legami
particolari con il regime fascista. Poi le sanzioni
internazionali della Società delle Nazioni paralizzarono completamente
la navigazione mercantile italiana. Le navi erano quasi
tutte adibite al trasporto di uomini e materiali bellico
verso la Quarta sponda, avendo Napoli come molo
d'imbarco preferito. Era il momento giusto per Lauro di
intrecciare rapporti più stretti con chi comandava a
Roma, facilitato in questa operazione dalla famiglia
Ciano che apparteneva anche lui al mondo degli armatori
navali. E così fu. Dopo di che, nel clima di espansione
territoriale del Fascismo verso la sponda africana, i
rapporti di don Achille con il regime diventarono
proficui. Non a caso, fu proprio il Fascismo - col quale
era in continuo contatti di affari - a ritenerlo utile
per la causa del Calcio Napoli e lo “istradò” nel 1935
verso la presidenza della società, bisognevole di aiuti
economici. E Lauro per compiacere il federale
partenopeo, in partenza per l’Africa, aderì al…
disinteressato invito, versando anche subito
trecentomila lire di tasca propria per contribuire a
ripianare i debiti della Società. Presidente del Napoli
dal 1936 al 1940 e poi (alla fine della Seconda Guerra
Mondiale), dal 1952 al 1954, Lauro preferì però in seguito
tenere le redini del sodalizio, ponendosi dietro le
quinte come presidente onorario, agendo dall'alto, nella
Società di calcio, attraverso persone di sua fiducia.
Egli fece la prima esperienza da dirigente del Napoli nel ruolo di
vicepresidente nel 1935, in un anno di transizione per
la squadra, che aveva cambiato allenatore, passando dal
grande Garbutt ad un nuovo straniero, l'ungherese
Csapkay, e nel mentre cominciava tristemente a declinare
la stella di Attila Sallustro.
La Società fu pervasa in quel momento da grandi velleità, con
un'impegnativa campagna acquisti, favorita dall'ingresso
come soci di facoltosi imprenditori. Il presidente,
l'ingegner Savarese, oscurato dal prestigio di Lauro,
venne indotto alle dimissioni e cominciò così, con la
nomina di Lauro alla presidenza del Napoli, il lungo
regno di don Achille: era il 1936. La situazione
economica della società non era brillante, ma Lauro,
uomo d'azione, poco incline a compromessi e mezze
misure, esordì come presidente con estrema decisione.
Angelo Mattea, il nuovo allenatore, accettò la lista di
proscrizione impostagli da Lauro. Vennero ceduti tutti i
giocatori che avevano piantato grane, alcuni anche di
valore. La classifica fu, però, modesta e Lauro continuò
nei tagli economici, cercando in economia rinforzi su
tutti i fronti. Anche il campionato successivo non fu
particolarmente brillante ed il Comandante, infuriato,
se la prese con l'allenatore che licenziò in tronco. La
squadra era deludente ed entrò in crisi il rapporto con
don Achille, il quale, amareggiato anche per le numerose
critiche alla sua conduzione definita dittatoriale,
lasciò la società nelle mani dell'ingegner Del Pozzo e
di Leonetti, mentre all'orizzonte incombeva minacciosa
la seconda guerra mondiale. Con l’infuriare dei
combattimenti e prima della sospensione del campionato
per motivi bellici, il Napoli mestamente nel 1941-42
subiva l'onta della prima retrocessione nella serie
cadetta. Ma alla sua guida non c’era più Lauro che aveva
ceduto il comando della Società al Grand' Ufficiale Luigi
Piscitelli. (Nella foto, Benito Mussolini in visita a
Lauro, nella tenuta di Sorrento)
DOPO CINQUE ANNI SI STANCO’ DEL CALCIO
- Lauro, in effetti, era intristito di guidare una
squadra deludente ed era anche stanco di sborsare
quattrini a vuoto. Lui sempre così sensibile al danaro.
C’è da considerare, comunque, che molti dei profitti
realizzati dalla Flotta in quel periodo gli erano stati
garantiti dal trasporto di soldati, armi e materiale
bellico tra l’Italia e l’Africa per conto del Fascismo,
(che, come abbiamo visto, lo aveva voluto presidente del
Napoli) anche se questa “collaborazione” provocò poi
all’arrivo degli Alleati a Napoli il suo arresto. Il
palazzo Lauro di Via Crispi fu requisito dagli americani
(che vi fissarono il loro Quartier Generale) e la sua
attività fu messa sotto sequestro, un’attività peraltro
ridotta ai minimi termini, a seguito dei danni patiti
dalla sua Flotta, durante gli incessanti bombardamenti
degli anglo-americani ai convogli italiani nel
Mediterraneo. La superiorità schiacciante del nemico,
dotato di radar, fece sì che alla fine delle ostilità si
salvassero solo poche navi, quelle tenute lontane dal
teatro delle operazioni. Le altre, erano state tutte inesorabilmente
colate a picco dai siluri avversari. Don Achille soffrì
molto per questa ecatombe. Nel 1942, grazie alla
presentazione di Ciano, era riuscito anche a farsi
ricevere dal Duce a Palazzo Venezia, al quale aveva
illustrato la situazione drammatica delle sue navi
affondate una dopo l'altra. Mussolini lo aveva
ringraziato offrendoglì come forma di risarcimento la
comproprietà al 50% di tutti i quotidiani napoletani
dell'epoca: "Il Mattino", " Corriere di Napoli", " Roma"
(l’altro pacchetto di azioni restò al Banco di Napoli).
Nel 1943, quando sbarcarono a Salerno le truppe americane, Lauro rimase a
Napoli, credendo che i suoi forti rapporti di amicizia e
di affari sulla “piazza” di Londra potessero funzionare
da parafulmine, ma purtroppo un suo vecchio
collaboratore inglese, un consulente di nome Williams,
lo aveva tradito denunciandolo come colluso col
fascismo. All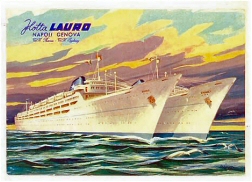 a
fine, la Commissione assolse, però, Lauro da tutte le
accuse, restituendogli la libertà il 22 giugno 1945.
Vane le proteste del governo militare alleato, per bocca
dell'avvocato Gordon . Lauro era rimasto in carcere per
22 mesi, tra Poggioreale ed i campi di prigionia di
Aversa, Padula e Terni. a
fine, la Commissione assolse, però, Lauro da tutte le
accuse, restituendogli la libertà il 22 giugno 1945.
Vane le proteste del governo militare alleato, per bocca
dell'avvocato Gordon . Lauro era rimasto in carcere per
22 mesi, tra Poggioreale ed i campi di prigionia di
Aversa, Padula e Terni.
LA
RICOSTRUZIONE DOPO LA GUERRA
- Quando fu liberato, Lauro era un uomo
ormai verso la sessantina, privato della sua precedente
ricchezza, avviato ad una tranquilla vecchiaia. Aveva
chiuso col Fascismo e con la guerra, ma il suo carattere
geniale, infaticabile ebbe naturalmente il sopravvento.
Di calcio, però, nemmeno a parlarne. C’era tutto da
ricostruire, la sua flotta giaceva in fondo al mare e
bisognava farla risorgere per la terza volta. Sette navi
erano semiaffondate in vari porti italiani e occorreva
recuperarle. Fu deciso che per prima si sarebbe dovuta
tirare su la "Ravello" colata a picco a La Spezia, ma
Lauro dovette fare i conti con gli operai liguri,
“comunisti” sfegatati che conoscevano i suoi precedenti.
Ma li conquistò con il suo modo di fare, col suo fascino
di uomo di mare. E in due giorni la nave fu recuperata.
In seguito vennero riportate a galla tutte le altre navi affondate
nei porti italiani, alle quali si affiancarono due
piccole portaerei americane in disarmo, acquistate sul
mercato e trasformate in due magnifici transatlantici,
la "Sidney" e la "Surriento", che cominciarono a
percorrere la rotta per l'Australia. In pochi anni la
Flotta napoletana conterà quaranta unità per un totale
di seicentocinquantamila tonnellate di stazza, tutte
navi battenti bandiera italiana che davano lavoro ad
oltre diecimila famiglie di marinai ed impiegati, quasi
tutti napoletani. Un grande motivo di orgoglio. Lauro
riprese, così, con maggiore lena l’attività di armatore,
ottenendo cospicui risultati che gli consentirono
qualche anno dopo non solo di rimettere radici nel
Calcio Napoli, ma soprattutto di realizzare una
imponente ascesa imprenditoriale e di conquistare un
posto di rilievo nell’attività politica.
Grazie al suo intuito, accompagnato da una certa spregiudicatezza, il
Comandante aveva acquistato anche alcune navi Liberty
usate dagli americani per i loro trasporti durante la
guerra, le rimodernò, sfruttò l’alto costo dei noli
marittimi dovuti alle difficoltà di utilizzare strade e
ferrovie andate in rovina per la guerra, intuì che
l’emigrazione dall’Italia era destinata soprattutto
verso l’ Australia e riportò in pochi anni la Flotta
Lauro a ricoprire il ruolo di unica grande azienda
meridionale privata a dimensione mondiale. (Nella
foto, una pubblicità della Flotta Lauro)
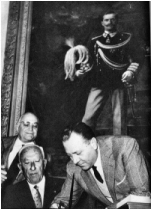
QUANDO SCESE IN POLITICA
- Il rilancio della Flotta, naturalmente, non poteva realizzarsi senza
l’appoggio dei governanti di quegli anni, impegnati a
raccogliere consensi e uomini per combattere la minaccia
comunista. Fu così che Lauro nel 1947 scese in
politica. Cominciò inglobando, alla vigilia delle
elezioni del 1948, gli uomini che Guglielmo Giannini
aveva raccolto intorno al partito dell’Uomo Qualunque,
incanalando i loro voti verso lo schieramento
democristiano di De Gasperi che – grazie a Lauro –
riuscì a formare il suo primo governo senza i
social-comunisti. Poi, con i suoi milioni, don Achille tolse dai
debiti e comprò la sezione napoletana del Partito
Monarchico, un partito che a Napoli vantava una
tradizione e aveva ancora molte simpatie, cominciando a
percorrere una strada politica in maniera più autonoma a
redditizia, spesso anche in contrasto con la
D.C.
Arrivò così il momento magico. In tutte le sue attività, ogni
decisione era presa soltanto da lui, socio di
maggioranza, al quale spettavano di diritto la
rappresentanza legale e la firma di approvazione di
qualsiasi atto. Così nella Flotta, così nel Calcio
Napoli, così in politica. All'inizio degli anni
Cinquanta la sua potenza economica e finanziaria era
eccezionale, possedeva la più grossa Flotta privata
d'Europa ed il suo giro d'affari sfiorava, secondo
accreditate fonti, i trecento miliardi l'anno, in
coincidenza con la guerra di Corea e la crisi del
petrolio prodotta dall'esplosiva situazione in
Medioriente.
Nel dopoguerra fu necessario, del resto, per gli armatori entrare
nel gioco della politica al fine di poter fronteggiare
la crisi dei noli. La prima lotta fu l'accaparramento
delle navi Liberty abbandonate dagli americani, e Lauro,
come abbiamo visto, fu tra i primi ad approfittarne.
Quindi le lobby si mossero per l'elaborazione di tutta
una serie di leggi a favore della navigazione, dagli
sgravi fiscali agli incentivi per rotte particolari, dai
contributi a fondo perduto alle esenzioni doganali.
Anche Lauro entrò, quindi, nel giro politico per trarne
tutti i vantaggi possibili.
Ma stavolta non restò ai margini, come aveva fatto con il
Fascismo negli Anni Trenta. Forte della sua posizione,
nel 1952, il Comandante riuscì a insediarsi con un largo
plebiscito al Comune di Napoli, confidando anche dei
sentimenti politici del popolo napoletano allora,
come sempre in passato, sensibile alle promesse e ai capi-popolo.
Alla testa di un gruppo eterogeneo composto di
nostalgici monarchici, di post-fascisti, di un
sottoproletariato napoletano affamato di “poltrone”, il
Comandante conquistò facilmente adesioni, in cambio di
voti, mentre trovò sostegni nei palazzinari che poi
ebbero vita facile nel saccheggio urbanistico della
città.
I risultati alle comunali del 1952 furono
un trionfo per Lauro: 117.000 preferenze. Nello stesso
tempo la coalizione di destra, con 208.000 voti,
conquistò 53 seggi, contro i 15 della Dc ed i 12 della
sinistra. Il 7 luglio con 50 voti, su 73 consiglieri
presenti in aula, Lauro venne eletto così sindaco di
Napoli e tenne – è il caso di dire - il suo “discorso
della Corona”. I napoletani spiegavano così il loro
voto: “Il Comandante è già molto ricco, non ha bisogno
di rubare! ", ma a speculare sulla situazione ci
pensarono altri, la grande e disinvolta “corte” laurina, facendo
danni e riempiendosi le tasche, Da sottolineare che don
Achille pretese e mise al servizio della sua attività
politica, esercitata attraverso varie sigle e
schieramenti,
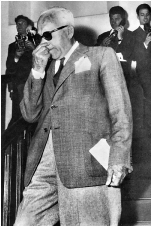 anche
la squadra azzurra di calcio, con lunghi e scomodi
viaggi, partite amichevoli a scopo elettorale,
provocando anche reazioni di fastidio da parte di alcuni
atleti. Ma tant’è. Il Comandante-presidente si
considerava padrone del vapore fino in fondo e ne
approfittò, con la sua solita arroganza, come capo
onnipotente, sprezzante anche dei “voleri” del Palazzo
romano, lui il più applaudito portavoce delle
rivendicazioni del Sud. (Nella foto, in alto,
Achille Lauro e Alfredo Covelli,
due monarchici di spicco del dopoguerra, ripresi mentre firmano un
documento all'ombra del re...) anche
la squadra azzurra di calcio, con lunghi e scomodi
viaggi, partite amichevoli a scopo elettorale,
provocando anche reazioni di fastidio da parte di alcuni
atleti. Ma tant’è. Il Comandante-presidente si
considerava padrone del vapore fino in fondo e ne
approfittò, con la sua solita arroganza, come capo
onnipotente, sprezzante anche dei “voleri” del Palazzo
romano, lui il più applaudito portavoce delle
rivendicazioni del Sud. (Nella foto, in alto,
Achille Lauro e Alfredo Covelli,
due monarchici di spicco del dopoguerra, ripresi mentre firmano un
documento all'ombra del re...)
DOPO IL SUCCESSO ELETTORALE,
IL TONFO - La disinvoltura
amministrativa con cui Lauro, come nelle altre sue
attività, il calcio e la Flotta, trattava la cosa
pubblica, facilitarono, però, lo scioglimento della
Giunta comunale laurina per irregolarità amministrative.
Evidentemente le forze politiche nazionali che erano al
potere non avevano gradito molto la sua riconquista del
Comune nelle elezioni del 1956. Anche allora fu un successo senza
precedenti: 276.000 preferenze al capolista Lauro, i
monarchici ottennero la maggioranza assoluta con il
51,7% dei voti e 44 seggi, mentre la Democrazia
Cristiana finiva umiliata con il 16%, superata anche dai
comunisti, col 19%. Nel 1958 con lo scioglimento del
Consiglio Comunale ( sotto l’offensiva della D.C. furono
riscontrate gravi, diffuse, sistematiche irregolarità e
deficienze) e la sconfitta del suo partito nelle
elezioni, prese il via la parabola politica discendente
dell’ultra settantenne Comandante. E dire che proprio in
quegli ultimi tempi il Comandante aveva cercato con
gigantesche e spettacolari battaglie elettorali, di
conquistare tutto il Sud, sbarcando con i suoi mezzi in
Sardegna e in Sicilia. Invece degli strombazzati due
milioni di voti nelle elezioni del ’58 ne arrivarono a
mala pena 700 mila. Per Lauro un ciclo storico
irripetibile si era chiuso. Gli restò per alcuni anni il
Calcio Napoli. E continuò a battersi come un leone. La
vicenda terrena dell’ultimo Re di Napoli o l’ultimo Borbone, come amava definirlo Antonio Ghirelli, si
chiuderà il 15 novembre dell’82, a novantacinque anni,
oberato di debiti, col fallimento in vista e con una grande
amarezza, dopo aver assistito al crollo di tutto ciò che
col suo lavoro e la sua abilità aveva costruito. Due
anni prima, il giorno dei morti, dopo 120 anni di
storia, si era spento anche il " Roma", il suo
quotidiano (che per fortuna dopo dieci anni avrà
nuova vita). Il crack era completo, in tutti i campi.
Intorno a lui non aveva trovato molti uomini all’altezza
del compito (specialmente nel periodo di maggiore
splendore), ma fu circondato da tanti cortigiani avidi,
pronti all’ossequio, ad arricchirsi ed a tradire.
(Nella foto, in alto a destra, il Comandante sente puzza di bruciato
intorno a se e allenta l'impegno politico)
LO
CHIAMAVANO "IL PRIAPO DI SORRENTO"
- Prima di tornare a trattare la seconda fase di Lauro
come presidente del Calcio Napoli (quella del
dopoguerra), occorre per completezza d’informazione fare
un cenno anche all’attività amatoria dell’esuberante
Comandante, un'attività molto chiacchierata. Tra realtà,
rivelazioni, leggende metropolitane, aneddoti, cronache
amene, la storia di quell’affascinante “marinaio” di
lungo corso fu infarcita da avventure, passioni,
pizzicotti in ascensori, avances esplicite alle
collaboratrici al Comune e alla Flotta e
successivamente, in età veneranda, viaggi rivitalizzanti
in Svizzera, cure Voronoff personalizzate, “piscioni”
vantati e mostrati, ed anche un paio di figli naturali
(uno fu costretto poi a riconoscere). Il tutto alle
spalle della mite e paziente donn’Angelina. Fino a
giungere al travolgente amore senile per Eliana Merolla,
in arte Kim Capri, bella e giovane attricetta figlia di
un negoziante di Via Toledo. Lauro allestì anche un film
per la giovane, tutto a sue spese, ma sulla celluloide
il risulta to
fu disastroso. La bionda Eliana divenne poi sua moglie
nel 1970, quando don Achille, ormai vedovo, aveva 83
anni. L'aveva conosciuta a 69 anni e lei appena 16. Non
ebbe figli dalla giovane moglie. Adottarono dopo poco la
piccola Tania, una bella bimba vietnamita. Comunque,
Lauro fu un impenitente Don Giovanni, novello Priapo in
gioventù, ma dalla virilità straripante, fino
all’ultimo. Se fosse vissuto ai giorni nostri sarebbe
stato certamente tra i più accaniti e fedeli consumatori
di Viagra. (Nella foto, a sinistra, del 1972, il
Comandante Lauro ripreso con la giovane moglie Eliana e
con la figlia adottiva Tania, vietnamita). to
fu disastroso. La bionda Eliana divenne poi sua moglie
nel 1970, quando don Achille, ormai vedovo, aveva 83
anni. L'aveva conosciuta a 69 anni e lei appena 16. Non
ebbe figli dalla giovane moglie. Adottarono dopo poco la
piccola Tania, una bella bimba vietnamita. Comunque,
Lauro fu un impenitente Don Giovanni, novello Priapo in
gioventù, ma dalla virilità straripante, fino
all’ultimo. Se fosse vissuto ai giorni nostri sarebbe
stato certamente tra i più accaniti e fedeli consumatori
di Viagra. (Nella foto, a sinistra, del 1972, il
Comandante Lauro ripreso con la giovane moglie Eliana e
con la figlia adottiva Tania, vietnamita).
IL
PRESIDENTE DEGLI ANNI 50
- Ma, con un grande passo indietro, lasciamo gli amori
e la politica di Lauro e torniamo al Calcio Napoli, l’altro suo
grande amore. Fu il secondo ciclo azzurro del
Comandante. Nei primi
anni del dopoguerra, Lauro tutto impegnato nella
ricostruzione della sua Flotta, si era tenuto lontano dal
football. Quando, però, nel Calcio Napoli la situazione
sembrò avviarsi allo sbando con la morte improvvisa per
infarto del presidente Egidio Musollino, Lauro non
seppe resistere a lungo a quanti lo pregavano di tornare
alla guida della società azzurra. Don Achille mise mano
al portafoglio e acquistò numerosi giocatori. Con il
nuovo presidente subentrò tra i tifosi l'euforia per lo
squadrone, ed il Comandante decise di coniugare il
calcio con la politica che nel frattempo lo stava
conquista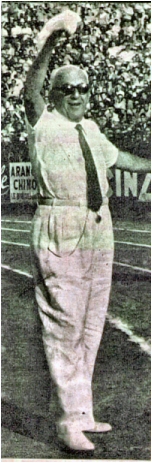 ndo.
Non gli poteva sfuggire, del resto, l'importanza strategica di
identificarsi con una squadra amata da centinaia di
migliaia di persone. Alla vigilia delle elezioni del
1952, assecondò, quindi, questi entusiasmi, accettando
uno slogan efficacissimo coniato dai suoi fedelissimi:
"Per un grande Napoli, per una grande Napoli, vota
Achille Lauro numero uno di Stella e Corona". I
risultati furono gratificanti, Lauro stracciò tutti con
una valanga di voti, divenne sindaco e non deluse i suo
tifosi. Fu di parola, realizzando l’ingaggio storico di Hasse Jeppson, per la vertiginosa cifra di 105 milioni.
Acquisto al quale si aggiunse, successivamente, quello
altrettanto prestigioso di Vinicio. ndo.
Non gli poteva sfuggire, del resto, l'importanza strategica di
identificarsi con una squadra amata da centinaia di
migliaia di persone. Alla vigilia delle elezioni del
1952, assecondò, quindi, questi entusiasmi, accettando
uno slogan efficacissimo coniato dai suoi fedelissimi:
"Per un grande Napoli, per una grande Napoli, vota
Achille Lauro numero uno di Stella e Corona". I
risultati furono gratificanti, Lauro stracciò tutti con
una valanga di voti, divenne sindaco e non deluse i suo
tifosi. Fu di parola, realizzando l’ingaggio storico di Hasse Jeppson, per la vertiginosa cifra di 105 milioni.
Acquisto al quale si aggiunse, successivamente, quello
altrettanto prestigioso di Vinicio.
Purtroppo la coesistenza di Luis con Jeppson, che avrebbe dovuto
regalare al Napoli traguardi più ambiziosi, si rivelò
difficile. Erano due giocatori eccezionali, ma di
temperamento e di scuola molto diversi: freddo e
calcolatore lo svedese, esuberante il brasiliano. Non
mancarono screzi, che videro protagonista anche
Monzeglio, un allenatore abilissimo, ma che col tempo
aveva perso autorità. La disciplina ne soffriva ed il
rapporto col Comandante, presidente onorario, ma sempre
“il capo” grazie alla sua disponibilità economica, andò
scemando. Lauro in cuor suo avrebbe preferito Amadei
come allenatore ed alla prima occasione propizia
licenziò in tronco Monzeglio, promuovendo il frascatano
sulla panchina. Questi, a differenza del suo
predecessore, penderà dalle labbra del Comandante, che
era consultato quotidianamente alle prime luci dell'alba
nella sua villa di via Crispi, durante la sua ginnastica
e colazione mattutina, quasi in costume adamitico,
ascoltando, ben disposto a tutti i voleri del capo.
Amadei otterrà anche un quarto posto, ma Lauro si
aspettava di più e gli consegnò il benservito, assumendo
Frossi, il quale portò a Napoli, oltre ad una disciplina
ferrea, il suo ben noto catenaccio. Ma la fortuna non
gli fu alleata e don Achille superstizioso, lo esonerò,
convinto, che la colpa fosse …anche delle lenti nere
che il mister portava giorno e notte. Nonostante i cambi
continui di allenatori ed un parco giocatori tutto
sommato dignitoso, il Napoli conobbe però di nuovo
l'onta della retrocessione. E in B fini due volte nel
giro di tre anni, nel 1961 e nel 1963. Gli scarsi
risultati della squadra lasciarono il segno sul
Comandante. Poi arrivò il giorno nerissimo per il Napoli
ed il suo presidente onorario, con la prima clamorosa
invasione di campo nell’ancora nuovo San Paolo,
nell’aprile del 1963, gara col Modena, lo stadio nelle
mani dei vandali invasori, porte distrutte, danni
ingenti. Un episodio vergognoso.
II calo d'immagine di don Achille stava lasciando segni
visibilissimi, anche con una perdita di voti oltre
misura. La sua lista, abituata a maggioranze assolute
schiaccianti, raggiunse un misero 11%. La situazione
societaria era divenuta, intanto, estremamente caotica
e Lauro, amareggiato, fece capire chiaramente che si era
stancato di continuare a sopportare da solo il peso
della società. Occorre ricordare che in tutti questi
anni come presidente del sodalizio figurava, del resto,
Alfonso Cuomo, un industriale conserviero, molto mite e
signorile, ma Cuomo per dieci stagioni fu semplicemente
un prestanome, perché tutte le decisioni venivano
ovviamente prese dal Comandante. Persino l’incasso delle
partite era prelevato da un addetto della Flotta, il dr.
Manfellotto, e trasferito in Via Marina, nel Palazzo
Lauro. Dalla barca che stava affondando don Achille,
stavolta scappò e si mise da parte. La situazione della
società era disperata. Persino il Prefetto venne
interessato dal governo a cercare una soluzione.
(Nella foto, Lauro in un suo caratteristico
atteggiamento negli anni dei successi : saluta la folla
del Vomero sventolando il fazzoletto)

LE
PARENTESI DI FIORE
E GIOACCHINO- Per fortuna,
si trovò il modo di creare una diversa struttura
proprietaria al sodalizio azzurro. Nacque così a Napoli la prima Società per
Azioni nel mondo del calcio, largamente in anticipo
sulle norme federali, con un capitale nominale di 120
milioni così suddiviso: 40% a Lauro, 22% a Corcione,
costruttore edile e 34% a Roberto Fiore, che divenne
anche presidente del Napoli. Seguì un periodo fecondo
per la società azzurra, con l’arrivo di due grandi
giocatori, Altafini e di Sivori, quest’ultimo grazie
all’interessamento diretto di Lauro che convinse Agnelli
a cedere l’asso argentino ( in rotta con l’allenatore
Heriberto) in cambio di un contratto per la fornitura
dei motori di due transatlantici gemelli in quel momento
in costruzione. I due campioni riavvicinarono e fecero
impazzire la folla. Subito un terzo posto, poi l'anno
successivo un quinto posto. Fu davvero un bel Napoli.
Mentre la squadra finalmente raccoglieva lusinghieri successi sul
campo, la società soffriva di rivalità e lotte interne.
Il presidente Fiore, messo in minoranza dal gruppo
laurino ( geloso dei risultati del nuovo presidente?)
nel dicembre del 1967 veniva costretto a rassegnare le
dimissioni, lasciando il suo posto a Gioacchino, il
figlio terribile e incontrollabile che don Achille volle
presidente. Egli condurrà una gestione
paternalistica della società, sotto l'ala protettrice
del padre-padrone, con il portafoglio sempre pronto ad
aprirsi anche di fronte ad affari discutibili. Unico
grande colpo: l’acquisto di Zoff. Poi un mare di guai.
Don Achille fu persino costretto ad interdirlo. Un male
incurabile stroncò Gioacchino, ancora giovane. Il Comandante fu
assente ai funerali del figlio . " Sapete - disse
- i funerali mi fanno impressione" (Nella foto,
Gioacchino Lauro con il dirigente azzurro Antonio Corcione)
FERLAINO
GLI STRAPPO’ LA SCENA
- Dopo un breve interregno di Antonio Corcione, si stava
preparando a comparire sulla scena del Napoli la figura di un
giovane ingegnere, costruttore edile, amante delle auto
velocissime: Corrado Ferlaino. Il suo impero in azzurro
durerà 33 anni e finalmente porterà lo scudetto, ben due
volte, all'ombra del Vesuvio.
Ferlaino seppe conquistarsi la presidenza con abilità, sfruttando
un Consiglio dove due fazioni, una favorevole a Lauro e
l'altra contraria, si contendevano la presidenza. Il
rappresentante del Comandante, l'avvocato Diamante, gli
diede fiducia, perché a don Achille
 era
piaciuto quel giovane così deciso, ma che evidentemente
non gli faceva ombra. L'apparentemente docile Ferlaino, invece, riuscì a
procurarsi anche il pacchetto azionario di Corcione e
infine pure quello di Fiore. Rocambolesco l'acquisto della
quota in possesso della vedova Corcione, abitante ad un
settimo piano di Via Manzoni. Mentre Fiore saliva
lentamente in ascensore, l'ingegnere, più giovane e
scattante, percorrendo di corsa le scale, arrivò per
primo dalla vedova Corcione e concluse l'affare. era
piaciuto quel giovane così deciso, ma che evidentemente
non gli faceva ombra. L'apparentemente docile Ferlaino, invece, riuscì a
procurarsi anche il pacchetto azionario di Corcione e
infine pure quello di Fiore. Rocambolesco l'acquisto della
quota in possesso della vedova Corcione, abitante ad un
settimo piano di Via Manzoni. Mentre Fiore saliva
lentamente in ascensore, l'ingegnere, più giovane e
scattante, percorrendo di corsa le scale, arrivò per
primo dalla vedova Corcione e concluse l'affare.
Achille Lauro non avrà più, da quel momento, una posizione di
rilievo nella società, rimarrà presidente a vita, ma il
destino del Napoli finì saldamente nelle mani di
Ferlaino, il quale, tra i tanti meriti e diversi errori,
porterà in azzurro Diego Armando Maradona, e con lui
due scudetti ed una Coppa Uefa. (Nella foto, Lauro
presenta il suo successore, un posato Corrado Ferlaino)
Roberto
Fiore, il “presidente tecnico”
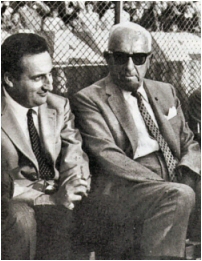
Roberto
Fiore , il vulcanico “presidente tecnico” del Napoli
Anni Sessanta, nacque col destino di presidente. Dotato
di gran fiuto organizzativo, e di una buona dose di
competenza calcistica, ebbe sempre di mira una
presidenza qualunque, nel Napoli, nell’Ischia, nella
Juve Stabia, nel calcio, nella pallanuoto (col Posillipo
scudettato), mordendo il freno quando – prima nel
Napoli, poi nella Lazio - dovette accontentarsi di
semplici ruoli dirigenziali. Divenne il presidente del
grande rilancio azzurro, dall’intuito imbattibile, non
solo sul piano tecnico, ma anche sul fronte manageriale.
Fu una presidenza breve, la sua, dal 1964 al 1966, ma
ricca di risultati. Bisogna risalire a Giorgio Ascarelli,
negli Anni Trenta, per ritrovare una simile svolta
radicale e rapida nel Napoli. In solo tre stagioni
Roberto Fiore ottenne prima l’immediata promozione dalla
Serie B, poi un luminoso terzo posto in Serie A insieme
con la vittoria nella Coppa delle Alpi, infine un quarto
posto in A, sempre con il fido Pesaola in panchina (che
era stato accantonato da Lauro). Finchè non fu
costretto, durante quest’ultimo campionato, per le
invidie del Comandante (che era rimasto padrone della
cassaforte) a lasciare il posto al figlio, “principe
ereditario” Gioacchino Lauro. Mai in passato gli azzurri
, terzi in classifica, si erano trovati così vicino allo
scudetto, e Fiore ebbe il grande merito di far uscire il
Napoli del periodo di oscurantismo in cui l’aveva fatto
piombare Achille Lauro, dando anche vita, durante la sua
presidenza, alla Società Sportiva Calcio Napoli, il
primo progetto di società per azioni in Italia, secondo
lo schema voluto dalla Federcalcio.
Fiore era nato a Bellavista il 2 ottobre del 1924, ed
ebbe la prima esperienza di presidente con il Vasto, una
squadretta del quartiere dove la famiglia si era
trasferita ed il papà aveva un bar molto accorsato che
rivaleggiava con quello di “Pippone” in Via Santa
Brigida, come covo del tifo azzurro. Suo padre Francesco
era anche un validissimo poeta che scriveva canzoni in
coppia con il maestro Lama, indimenticato autore di
“Reginella”. A vent’anni compose con Gambardella (
autore de ‘O marinariello”) “’A cchiù bella d’e’
figliole”. La sua più nota canzone fu “Bellavista” del
1939. Musicarono i suoi versi anche Valente jr. Nardella,
Cioffi, Falvo, Tagliaferri, Bonavolontà e Vian. Suo
fratello Renato era figlio d’arte. Aveva composto
“Suonno a Marechiaro”, interpretata da Sergio Bruni e
Mario Abbate e “Ma pecchè” cantata da Iva Zanicchi, “
Ammore celeste” e “Senza ‘e te”, mentre il nipote Angelo
aveva cantato e composto per Sergio Bruni. Con questi
illustri precedenti, invece di comporre anche lui versi
o musicare canzoni, Roberto Fiore preferì agire da
“organizzatore” in campo calcistico , fino a giungere
nel 1964 alla poltrona di Achille Lauro nel Napoli.
(Nella foto, Roberto Fiore al Vomero con Lauro)
GIGINO
SCUOTTO GLI APRI’ LE PORTE
- Nel 1963, dopo la quarta retrocessione in serie B
della storia del club azzurro, Lauro presidente onorario
(Alfonso Cuomo figurava come presidente effettivo) aveva
deciso di passare la mano, ma pretendeva oltre 400
milioni a saldo per personali contribuzioni non
documentate, perché mai nessun rendiconto era stato
stilato in società. Il deficit della società ammontava
addirittura a settecento milioni. Vani i tentativi di
chiudere un accordo sulla vicenda. Respinte varie
proposte giudicate insufficienti, il Comandante accettò
la nomina di Scuotto, scelto dalla Federcalcio e dalla
Lega come commissario straordinario, e ribattezzato
“reggente povero”. Fu a quel punto che Scuotto chiese la
collaborazione al suo fianco di un giovane dirigente,
Roberto Fiore, traghettando il Napoli verso un anonimo
ottavo posto in B.
 NEL
PRIMO ANNO SUBITO PROMOZIONE IN A
– Nella stagione 1964-65
si avvertì subito la necessità di costituire la nuova
società, fino ad allora retta da Scuotto. Questi pilotò
verso la presidenza Giovanni Proto, consigliere comunale
per il partito monarchico. L’intesa con Lauro, dello
stesso partito, sembrava possibile. Ma al momento della
firma, nella sede della Federcalcio a Roma, il
Comandante non volle saperne di lasciare definitivamente
la scena ma intendeva solo trovare nuovi collaboratori e
finanziatori. Un altro, insomma, come l’ex presidente
Alfonso Cuomo, disposto ad avallare cambiali. Proto,
sdegnato dal tradimento di Lauro, strappò la tessera del
partito (rimase nel Consiglio Comunale come
indipendente) e spostò i suoi interessi verso il Cirio,
trasformandolo in Internapoli in Serie D, e scoprendo
Chinaglia e Wilson. Successivamente, a fatica, venne
varata la S.S.C Napoli che si accollava oneri e debiti
della vecchia A.C. Napoli di Ascarelli che era in
liquidazione. Fiore fu eletto presidente con Lauro che
tornò alla presidenza onoraria. Nella costituzione della
Società il capitale sociale di 120 milioni fu
sottoscritto subito da Achille Lauro (defalcando i suoi
40 milioni dai 480 del suo credito consolidato, vantato
e mai dimostrato), e da Gigino Scuotto con 17 milioni.
Il neo presidente Fiore, nel momento del suo
insediamento, trovò che restavano da pagare debiti per
423 milioni. A questo punto comparve un nuovo socio:
Gioacchino Lauro (primogenito del Comandante); ma
mancavano ancora 40 milioni dal Gruppo Fiore e 40
milioni da Corcione-Tardugno. La situazione non era,
quindi, affatto tranquilla. Comunque, nel primo anno da
presidente, Fiore in tandem con Pesaola centrò subito il
ritorno nella massima divisione, ricreando a Napoli un
clima di entusiasmo che mancava da tempo. Pesaola
promise, sin dai giorni del ritiro, il ritorno in Serie
A. La stagione degli azzurri fu quasi una marcia
trionfale. Alla fine arrivò il secondo posto ad un punto
dal Brescia. "Nell'ultima di campionato" racconta Bruno
Pesaola "a Parma ci giocammo la serie A e fu come se
fossimo stati al San Paolo. La città emiliana era stata
invasa da napoletani. C'erano diecimila tifosi azzurri ,
ed almeno altri mille erano rimasti fuori dallo stadio
perché non erano riusciti ad entrare". Erano le 18.10
quando De Marchi fischiò il 3-1 del ritorno del Napoli
in A, ed era la sua quarta risalita nei suoi cinquant'anni
di storia. L'entusiasmo divenne dilagante. Sia a Parma
(per Fiore fu necessaria un’iniezione di coramina) che
in città. Fu festa grande, con la Galleria Umberto I
gremita per la radiocronaca. Finì con un anticipo di
Piedigrotta. Questi i protagonisti, tutti primattori,
senza l'idolo assoluto (come lo erano stati Jeppson o
Vinicio in passato ): Bandoni, Adorni, Gatti, Mistone,
Ronzon, Panzanato, Emoli, Girardo, Zurlini, Canè,
Montefusco, Fanello, Juliano, Spanio, Tacchi, Bean,
Corelli, Bolzoni, Fraschini. Fu un bell’anno il 1965,
arricchito da altri trionfi napoletani: la Partenope
Rugby divenne Campione d'Italia e la Partenope Basket fu
promossa in A. ( Nella foto, Pesaola fu
allenatore azzurro in tutte le tre stagioni di
Fiore) NEL
PRIMO ANNO SUBITO PROMOZIONE IN A
– Nella stagione 1964-65
si avvertì subito la necessità di costituire la nuova
società, fino ad allora retta da Scuotto. Questi pilotò
verso la presidenza Giovanni Proto, consigliere comunale
per il partito monarchico. L’intesa con Lauro, dello
stesso partito, sembrava possibile. Ma al momento della
firma, nella sede della Federcalcio a Roma, il
Comandante non volle saperne di lasciare definitivamente
la scena ma intendeva solo trovare nuovi collaboratori e
finanziatori. Un altro, insomma, come l’ex presidente
Alfonso Cuomo, disposto ad avallare cambiali. Proto,
sdegnato dal tradimento di Lauro, strappò la tessera del
partito (rimase nel Consiglio Comunale come
indipendente) e spostò i suoi interessi verso il Cirio,
trasformandolo in Internapoli in Serie D, e scoprendo
Chinaglia e Wilson. Successivamente, a fatica, venne
varata la S.S.C Napoli che si accollava oneri e debiti
della vecchia A.C. Napoli di Ascarelli che era in
liquidazione. Fiore fu eletto presidente con Lauro che
tornò alla presidenza onoraria. Nella costituzione della
Società il capitale sociale di 120 milioni fu
sottoscritto subito da Achille Lauro (defalcando i suoi
40 milioni dai 480 del suo credito consolidato, vantato
e mai dimostrato), e da Gigino Scuotto con 17 milioni.
Il neo presidente Fiore, nel momento del suo
insediamento, trovò che restavano da pagare debiti per
423 milioni. A questo punto comparve un nuovo socio:
Gioacchino Lauro (primogenito del Comandante); ma
mancavano ancora 40 milioni dal Gruppo Fiore e 40
milioni da Corcione-Tardugno. La situazione non era,
quindi, affatto tranquilla. Comunque, nel primo anno da
presidente, Fiore in tandem con Pesaola centrò subito il
ritorno nella massima divisione, ricreando a Napoli un
clima di entusiasmo che mancava da tempo. Pesaola
promise, sin dai giorni del ritiro, il ritorno in Serie
A. La stagione degli azzurri fu quasi una marcia
trionfale. Alla fine arrivò il secondo posto ad un punto
dal Brescia. "Nell'ultima di campionato" racconta Bruno
Pesaola "a Parma ci giocammo la serie A e fu come se
fossimo stati al San Paolo. La città emiliana era stata
invasa da napoletani. C'erano diecimila tifosi azzurri ,
ed almeno altri mille erano rimasti fuori dallo stadio
perché non erano riusciti ad entrare". Erano le 18.10
quando De Marchi fischiò il 3-1 del ritorno del Napoli
in A, ed era la sua quarta risalita nei suoi cinquant'anni
di storia. L'entusiasmo divenne dilagante. Sia a Parma
(per Fiore fu necessaria un’iniezione di coramina) che
in città. Fu festa grande, con la Galleria Umberto I
gremita per la radiocronaca. Finì con un anticipo di
Piedigrotta. Questi i protagonisti, tutti primattori,
senza l'idolo assoluto (come lo erano stati Jeppson o
Vinicio in passato ): Bandoni, Adorni, Gatti, Mistone,
Ronzon, Panzanato, Emoli, Girardo, Zurlini, Canè,
Montefusco, Fanello, Juliano, Spanio, Tacchi, Bean,
Corelli, Bolzoni, Fraschini. Fu un bell’anno il 1965,
arricchito da altri trionfi napoletani: la Partenope
Rugby divenne Campione d'Italia e la Partenope Basket fu
promossa in A. ( Nella foto, Pesaola fu
allenatore azzurro in tutte le tre stagioni di
Fiore)
 L’ACCOPPIATA
MAGNIFICA: ALTAFINI E SIVORI
- Una volta tornato tra le “grandi”, con intuito
felicissimo, Fiore acquistò dal Milan Josè Altafini e
dalla Juventus Omar Sivori. Il campione brasiliano era
in rotta con Gipo Viani che lo considerava “coniglio” e
lo aveva quasi venduto alla Juve, quando spuntò Fiore
con una proposta più allettante: 280 milioni. Il
presidente Felice Riva acconsentì, litigando però con
Viani che per protesta lasciò la società rossonera.
Ovviamente gran folla all’aeroporto di Capodichino per
salutare Altafini. Ma furono di più a radunarsi alla
stazione di Mergellina per accogliere Omar Sivori, il
secondo colpo di Fiore, il più applaudito argentino a
quei tempi sui campi italiani, che però era in aperto
contrasto con Heriberto Herrera, allenatore della Juve.
Nel suo rigido “ movimiento” non c’era L’ACCOPPIATA
MAGNIFICA: ALTAFINI E SIVORI
- Una volta tornato tra le “grandi”, con intuito
felicissimo, Fiore acquistò dal Milan Josè Altafini e
dalla Juventus Omar Sivori. Il campione brasiliano era
in rotta con Gipo Viani che lo considerava “coniglio” e
lo aveva quasi venduto alla Juve, quando spuntò Fiore
con una proposta più allettante: 280 milioni. Il
presidente Felice Riva acconsentì, litigando però con
Viani che per protesta lasciò la società rossonera.
Ovviamente gran folla all’aeroporto di Capodichino per
salutare Altafini. Ma furono di più a radunarsi alla
stazione di Mergellina per accogliere Omar Sivori, il
secondo colpo di Fiore, il più applaudito argentino a
quei tempi sui campi italiani, che però era in aperto
contrasto con Heriberto Herrera, allenatore della Juve.
Nel suo rigido “ movimiento” non c’era
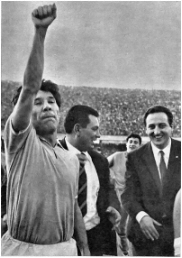 posto per le
estrosità di Omar. Erano corse anche parole grosse e
nello “stile Juve” non era ammissibile che un giocatore,
sia pure un artista come Sivori, osasse criticare
l’allenatore. Doveva andar via. Stava per essere
esiliato a Varese, quando Fiore contattò la Juve.
Occorrevano i soldi. E qui intervenne in maniera
meritoria il Comandante Lauro (presidente onorario) che,
grazie ai buoni rapporti d’affari che intercorrevano con
Agnelli, spuntò un accordo per novanta milioni, pagabili
in due anni, ed in cambio commissionò alla Fiat i motori
per due sue navi in allestimento, l’Achille Lauro e
l’Angelina Lauro. "Credo che sia stata la migliore
accoppiata vincente – ricorda Fiore - che ci sia stata
nel mondo del calcio negli ultimi decenni, che portò il
Napoli, il mio Napoli, tra il novero delle grandi
squadre. Stavo trattando, e l'intesa era a buon punto,
l'acquisto di Altafini dal Milan quando seppi – aggiunge
Fiore - da Emoli che Sivori stava per lasciare la
Juventus. C'era però un problema: la Juve era
interessata anche lei ad Altafini e quindi non mi potevo
presentare da Agnelli e chiedere Sivori". Quindi Fiore
decise di correre ad uno stratagemma: "Nell'albergo dove
si facevano le contrattazioni, parlando al telefono con
un mio amico ma fingendo di parlare con Sivori, dicevo a
voce alta che non potevo accettare le sue condizioni: 50
milioni di ingaggio, casa a Posillipo, autista e così
via, ma che potevamo metterci d'accordo. La notizia,
come previsto, fu ascoltata da qualche giornalista che
la riportò sui giornali e la Juve si ritrovò dinanzi al
fatto compiuto. Apprese della trattativa per via
indiretta. Piccole astuzie che facevano parte di un
altro calcio, molto più romantico. Per la sua cessione
pattuii la cifra di cento milioni che poi divennero 90
grazie all'interessamento di Lauro".
(Nelle foto, uno degli striscioni al San Paolo per
Fiore e Sivori esultante, al fianco di Fiore, dopo
il successo sul Milan per 1-0 con un suo gol) posto per le
estrosità di Omar. Erano corse anche parole grosse e
nello “stile Juve” non era ammissibile che un giocatore,
sia pure un artista come Sivori, osasse criticare
l’allenatore. Doveva andar via. Stava per essere
esiliato a Varese, quando Fiore contattò la Juve.
Occorrevano i soldi. E qui intervenne in maniera
meritoria il Comandante Lauro (presidente onorario) che,
grazie ai buoni rapporti d’affari che intercorrevano con
Agnelli, spuntò un accordo per novanta milioni, pagabili
in due anni, ed in cambio commissionò alla Fiat i motori
per due sue navi in allestimento, l’Achille Lauro e
l’Angelina Lauro. "Credo che sia stata la migliore
accoppiata vincente – ricorda Fiore - che ci sia stata
nel mondo del calcio negli ultimi decenni, che portò il
Napoli, il mio Napoli, tra il novero delle grandi
squadre. Stavo trattando, e l'intesa era a buon punto,
l'acquisto di Altafini dal Milan quando seppi – aggiunge
Fiore - da Emoli che Sivori stava per lasciare la
Juventus. C'era però un problema: la Juve era
interessata anche lei ad Altafini e quindi non mi potevo
presentare da Agnelli e chiedere Sivori". Quindi Fiore
decise di correre ad uno stratagemma: "Nell'albergo dove
si facevano le contrattazioni, parlando al telefono con
un mio amico ma fingendo di parlare con Sivori, dicevo a
voce alta che non potevo accettare le sue condizioni: 50
milioni di ingaggio, casa a Posillipo, autista e così
via, ma che potevamo metterci d'accordo. La notizia,
come previsto, fu ascoltata da qualche giornalista che
la riportò sui giornali e la Juve si ritrovò dinanzi al
fatto compiuto. Apprese della trattativa per via
indiretta. Piccole astuzie che facevano parte di un
altro calcio, molto più romantico. Per la sua cessione
pattuii la cifra di cento milioni che poi divennero 90
grazie all'interessamento di Lauro".
(Nelle foto, uno degli striscioni al San Paolo per
Fiore e Sivori esultante, al fianco di Fiore, dopo
il successo sul Milan per 1-0 con un suo gol)
 NAPOLI
TERZO, VICINO ALLO SCUDETTO
- Questi due campioni, insieme all'altro brasiliano Canè,
al giovane Juliano (destinato alla Nazionale) , a
Panzanato, a Bean, a Ronzon, a Bandoni, resero oltre le
loro possibilità. Il Napoli finì terzo con 45 punti, ad
un punto dal Bologna secondo e 5 punti
dall'Internazionale Campione d'Italia , prendendosi lo
sfizio di rovinare la festa del decimo scudetto ai
nerazzurri. Proprio nell'ultima di campionato piegò i
nerazzurri al San Paolo per 3 a 1, con una doppietta di
Altafini. Subito dopo vinse la Coppa delle Alpi ( torneo
italo-elvetico al quale presero parte, tra gli altri,
anche la Juventus, il Catania e la Spal). Un campionato
entusiasmante, con vittorie di prestigio e folla sempre
strabocchevole al San Paolo (ottocento milioni incassati
per abbonamenti) . Soprattutto osannato fu Sivori.
Numeri di classe finissima, avversari derisi, beffati:
Omar divenne per i tifosi una sorta di vendicatore,
l’uomo del riscatto, quello che, per dirla alla
napoletana, “toglieva i paccheri dalla faccia”. Alla
fine del secolo, Sivori ed i tifosi azzurri troveranno
in Maradona, un altro argentino fantasioso, un
degnissimo erede, come uomo delle rivincite. (Nella
foto, Sivori e Altafini) NAPOLI
TERZO, VICINO ALLO SCUDETTO
- Questi due campioni, insieme all'altro brasiliano Canè,
al giovane Juliano (destinato alla Nazionale) , a
Panzanato, a Bean, a Ronzon, a Bandoni, resero oltre le
loro possibilità. Il Napoli finì terzo con 45 punti, ad
un punto dal Bologna secondo e 5 punti
dall'Internazionale Campione d'Italia , prendendosi lo
sfizio di rovinare la festa del decimo scudetto ai
nerazzurri. Proprio nell'ultima di campionato piegò i
nerazzurri al San Paolo per 3 a 1, con una doppietta di
Altafini. Subito dopo vinse la Coppa delle Alpi ( torneo
italo-elvetico al quale presero parte, tra gli altri,
anche la Juventus, il Catania e la Spal). Un campionato
entusiasmante, con vittorie di prestigio e folla sempre
strabocchevole al San Paolo (ottocento milioni incassati
per abbonamenti) . Soprattutto osannato fu Sivori.
Numeri di classe finissima, avversari derisi, beffati:
Omar divenne per i tifosi una sorta di vendicatore,
l’uomo del riscatto, quello che, per dirla alla
napoletana, “toglieva i paccheri dalla faccia”. Alla
fine del secolo, Sivori ed i tifosi azzurri troveranno
in Maradona, un altro argentino fantasioso, un
degnissimo erede, come uomo delle rivincite. (Nella
foto, Sivori e Altafini)
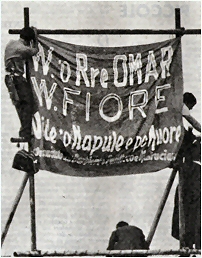 L’INVIDIA
DI LAURO LO COSTRINSE A DIMETTERSI
- Ma nella sua terza stagione (quarto posto) Fiore non
giunse alla fine. Don Roberto, che, a buon ragione,
poteva rivendicare gran parte del merito degli ultimi
successi, attirò su di se’ non poche invidie. Una parte
della dirigenza gli fu ostile e rese più palpabile una
certa precarietà economica della società, nonostante gli
incassi e i 69 mila abbonati. Bisognava stare vicino a
don Roberto, sostenerlo nelle sue modeste disponibilità
economiche. Invece, l'eccessiva popolarità di Fiore
aveva cominciato ad infastidire soprattutto Lauro che,
una volta riuscito a consolidare l'asse con Corcione,
fece di tutto per rendere difficile la vita a Fiore fino
a quando lo costrinse a dimettersi nel dicembre del
1966. Non ci fu la temuta sommossa ( sperata da Fiore)
tra i tifosi e Lauro ne approfittò. Dopo un periodo di
commissariamento dell'avvocato Diamante, i poteri
passarono, così, nelle mani dell'onorevole Gioacchino
Lauro, che non possedeva né le capacità né il carisma
del predecessore. La squadra, sull’abbrivio del lavoro
di Fiore, si classificò al quinto posto con 44 punti, ma
avrebbe potuto fare molto di più. Era un Napoli
splendido, con tre giocatori in Nazionale (Juliano,
Bianchi e Nardin), ma Lauro non lo capì. Più sensibili
della gran massa dei tifosi, rimasti indifferenti al
ritiro di Fiore, furono i calciatori azzurri: quando
seppero del suo addio, salirono a trovarlo a casa, in
Via Scarlatti, al quartiere del Vomero, per un festoso
saluto, che in realtà celava anche una sincera tristezza
ed un chiaro riconoscimento. I calciatori festeggiarono
Fiore, quasi in lacrime, con una medaglia ed una
semplice dedica: "Forza Presidente". (Nella foto,
l'allestimento di uno striscione per Sivori, ma anche
per Fiore, a dispetto di Achille Lauro) L’INVIDIA
DI LAURO LO COSTRINSE A DIMETTERSI
- Ma nella sua terza stagione (quarto posto) Fiore non
giunse alla fine. Don Roberto, che, a buon ragione,
poteva rivendicare gran parte del merito degli ultimi
successi, attirò su di se’ non poche invidie. Una parte
della dirigenza gli fu ostile e rese più palpabile una
certa precarietà economica della società, nonostante gli
incassi e i 69 mila abbonati. Bisognava stare vicino a
don Roberto, sostenerlo nelle sue modeste disponibilità
economiche. Invece, l'eccessiva popolarità di Fiore
aveva cominciato ad infastidire soprattutto Lauro che,
una volta riuscito a consolidare l'asse con Corcione,
fece di tutto per rendere difficile la vita a Fiore fino
a quando lo costrinse a dimettersi nel dicembre del
1966. Non ci fu la temuta sommossa ( sperata da Fiore)
tra i tifosi e Lauro ne approfittò. Dopo un periodo di
commissariamento dell'avvocato Diamante, i poteri
passarono, così, nelle mani dell'onorevole Gioacchino
Lauro, che non possedeva né le capacità né il carisma
del predecessore. La squadra, sull’abbrivio del lavoro
di Fiore, si classificò al quinto posto con 44 punti, ma
avrebbe potuto fare molto di più. Era un Napoli
splendido, con tre giocatori in Nazionale (Juliano,
Bianchi e Nardin), ma Lauro non lo capì. Più sensibili
della gran massa dei tifosi, rimasti indifferenti al
ritiro di Fiore, furono i calciatori azzurri: quando
seppero del suo addio, salirono a trovarlo a casa, in
Via Scarlatti, al quartiere del Vomero, per un festoso
saluto, che in realtà celava anche una sincera tristezza
ed un chiaro riconoscimento. I calciatori festeggiarono
Fiore, quasi in lacrime, con una medaglia ed una
semplice dedica: "Forza Presidente". (Nella foto,
l'allestimento di uno striscione per Sivori, ma anche
per Fiore, a dispetto di Achille Lauro)
 STAVA
PRENDENDO PELE’ IN PRESTITO
- Fiore è ricordato tra i tifosi soprattutto per aver
portato a Napoli Sivori ed Altafini, ma lui vorrebbe che
fosse ricordato anche per aver preso Claudio Sala, Bigon,
Bianchi e Panzanato. ”A Lauro – ricorda – proposi anche
l’acquisto di Aroldo, un altro brasiliano che giocò vari
anni in Nazionale, ma lui voleva i giocatori di peso e
poiché Aroldo era molto magro non acconsentì
all’acquisto. Così come gli consigliai Canè, ma lui lo
prese solo perché in fotografia era brutto e nero.
Diceva che faceva paura agli avversari. Ma Fiore non si
fermò a Sivori e Altafini. Pensava a Nils Liedholm per
il settore giovanile, e per rinforzare ancora di più la
squadra, puntava al famoso fantasista granata Gigi
Meroni, il cui acquisto fu ostacolato, praticamente
impedito, da Lauro e dai dirigenti Tardugno e Corcione,
probabilmente invidiosi dei successi di don Roberto, che
aveva anche arruolato 69 mila abbonati. E così l’affare
sfumò. Quello che non tutti sanno – ricorda il vulcanico
Fiore – è che proposi ad un manager brasiliano il
prestito per una sola stagione di Pelè per la faraonica
cifra di cento milioni. Pelè mi spedì anche una
cartolina e sembrava disposto a venire in Italia, per
questo esperimento, ma feci l’errore di accennare il mio
progetto a Sivori. Capii così che Omar non era affatto
entusiasta della mia idea e per evitare fratture nello
spogliatoio mandai a monte l’iniziativa.” Fiore
“presidente tecnico” non fu, quindi, definizione
sbagliata.( Nella foto, il grande Pelè: era entrato
nell'obiettivo di Fiore) STAVA
PRENDENDO PELE’ IN PRESTITO
- Fiore è ricordato tra i tifosi soprattutto per aver
portato a Napoli Sivori ed Altafini, ma lui vorrebbe che
fosse ricordato anche per aver preso Claudio Sala, Bigon,
Bianchi e Panzanato. ”A Lauro – ricorda – proposi anche
l’acquisto di Aroldo, un altro brasiliano che giocò vari
anni in Nazionale, ma lui voleva i giocatori di peso e
poiché Aroldo era molto magro non acconsentì
all’acquisto. Così come gli consigliai Canè, ma lui lo
prese solo perché in fotografia era brutto e nero.
Diceva che faceva paura agli avversari. Ma Fiore non si
fermò a Sivori e Altafini. Pensava a Nils Liedholm per
il settore giovanile, e per rinforzare ancora di più la
squadra, puntava al famoso fantasista granata Gigi
Meroni, il cui acquisto fu ostacolato, praticamente
impedito, da Lauro e dai dirigenti Tardugno e Corcione,
probabilmente invidiosi dei successi di don Roberto, che
aveva anche arruolato 69 mila abbonati. E così l’affare
sfumò. Quello che non tutti sanno – ricorda il vulcanico
Fiore – è che proposi ad un manager brasiliano il
prestito per una sola stagione di Pelè per la faraonica
cifra di cento milioni. Pelè mi spedì anche una
cartolina e sembrava disposto a venire in Italia, per
questo esperimento, ma feci l’errore di accennare il mio
progetto a Sivori. Capii così che Omar non era affatto
entusiasta della mia idea e per evitare fratture nello
spogliatoio mandai a monte l’iniziativa.” Fiore
“presidente tecnico” non fu, quindi, definizione
sbagliata.( Nella foto, il grande Pelè: era entrato
nell'obiettivo di Fiore)
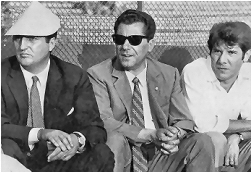 LA
BEFFA DELL’INGEGNERE
- Don Roberto stava
mettendo di nuovo le mani sul Napoli nel 1969, quando si
impegnò con altri dirigenti ad acquistare le azioni
della vedova del compianto Corcione per contrastare la
posizione dominante di Lauro, ma fu preceduto dallo
scatto di Ferlaino che, fatte le scale quattro a
quattro, (mentre Fiore aspettava l’ascensore che doveva
portarlo al settimo piano) riuscì ad infilarsi
nell’uscio un attimo prima che si chiudesse, offrendo
alla signora Corcione più del doppio (80 milioni) del
valore nominale (36 milioni) delle azioni del defunto
marito. Fiore, comunque, era convinto che Ferlaino
avesse agito per nome suo e del gruppo che aspirava ai
vertici, ma Corrado precisò subito dopo il blitz in Via
Manzoni: “ Le azioni le ho comprate io e sono mie!”
Vistosi ancora sconfitto, stretto nella morsa
Lauro-Ferlaino , Fiore dopo pochi giorni preferì vendere
all’usurpatore Ferlaino anche il suo 21% per
l’allettante somma di 183 milioni, oltre sette volte il
valore nominale che era di 25 milioni e 200 mila lire.
Comunque, fu un buon affare economico per don Roberto.
Così Ferlaino si impossessò della presidenza. ( Nella
foto, Corcione tra Fiore e Sivori, suo grande amico) LA
BEFFA DELL’INGEGNERE
- Don Roberto stava
mettendo di nuovo le mani sul Napoli nel 1969, quando si
impegnò con altri dirigenti ad acquistare le azioni
della vedova del compianto Corcione per contrastare la
posizione dominante di Lauro, ma fu preceduto dallo
scatto di Ferlaino che, fatte le scale quattro a
quattro, (mentre Fiore aspettava l’ascensore che doveva
portarlo al settimo piano) riuscì ad infilarsi
nell’uscio un attimo prima che si chiudesse, offrendo
alla signora Corcione più del doppio (80 milioni) del
valore nominale (36 milioni) delle azioni del defunto
marito. Fiore, comunque, era convinto che Ferlaino
avesse agito per nome suo e del gruppo che aspirava ai
vertici, ma Corrado precisò subito dopo il blitz in Via
Manzoni: “ Le azioni le ho comprate io e sono mie!”
Vistosi ancora sconfitto, stretto nella morsa
Lauro-Ferlaino , Fiore dopo pochi giorni preferì vendere
all’usurpatore Ferlaino anche il suo 21% per
l’allettante somma di 183 milioni, oltre sette volte il
valore nominale che era di 25 milioni e 200 mila lire.
Comunque, fu un buon affare economico per don Roberto.
Così Ferlaino si impossessò della presidenza. ( Nella
foto, Corcione tra Fiore e Sivori, suo grande amico)
 LA
SUA VERSIONE SULLA SCALATA DI FERLAINO
- Fiore, comunque, su questo notissimo episodio della
doppia scalata dell’ingegnere, nel palazzo di Corcione
in Via Manzoni e poi nel Calcio Napoli, con il suo
spirito bizzarro, dà una versione diversa, molto
napoletana, tutta scaramantica, che va riportata: “ Da
anni circola questo racconto diventato quasi una
leggenda. Quella volta non ci fu stratagemma. La verità
è che io sono una persona molto superstiziosa e avevo
notato che tutti i presidenti che mi avevano preceduto
morivano o fallivano. Ricordate Ascarelli, Musollino? I
più noti. Dopo anni che facevo il presidente della
società ero molto stanco e dissi al Comandante che
volevo fare solo l’amministratore delegato. Proposi
allora di fare eleggere presidente suo figlio Gioacchino
che morì quattro mesi dopo, a quasi cinquant’anni. Dopo
di lui fu nominato presidente Corcione che morì dopo sei
mesi per un tumore. E fu allora che dissi alla vedova
Corcione: “Il presidente facciamolo fare a Ferlaino” Ma
dietro questa mia decisione, lo assicuro, non c’era
neanche un pizzico di cattiveria.” Come si fa a
credergli, conoscendo i fatti veri di quel periodo?
(Nella foto, il Comandante Lauro tra il figlio
Gioacchino ed Andrea Torino, dirigente e grande amico di
Lauro) LA
SUA VERSIONE SULLA SCALATA DI FERLAINO
- Fiore, comunque, su questo notissimo episodio della
doppia scalata dell’ingegnere, nel palazzo di Corcione
in Via Manzoni e poi nel Calcio Napoli, con il suo
spirito bizzarro, dà una versione diversa, molto
napoletana, tutta scaramantica, che va riportata: “ Da
anni circola questo racconto diventato quasi una
leggenda. Quella volta non ci fu stratagemma. La verità
è che io sono una persona molto superstiziosa e avevo
notato che tutti i presidenti che mi avevano preceduto
morivano o fallivano. Ricordate Ascarelli, Musollino? I
più noti. Dopo anni che facevo il presidente della
società ero molto stanco e dissi al Comandante che
volevo fare solo l’amministratore delegato. Proposi
allora di fare eleggere presidente suo figlio Gioacchino
che morì quattro mesi dopo, a quasi cinquant’anni. Dopo
di lui fu nominato presidente Corcione che morì dopo sei
mesi per un tumore. E fu allora che dissi alla vedova
Corcione: “Il presidente facciamolo fare a Ferlaino” Ma
dietro questa mia decisione, lo assicuro, non c’era
neanche un pizzico di cattiveria.” Come si fa a
credergli, conoscendo i fatti veri di quel periodo?
(Nella foto, il Comandante Lauro tra il figlio
Gioacchino ed Andrea Torino, dirigente e grande amico di
Lauro)
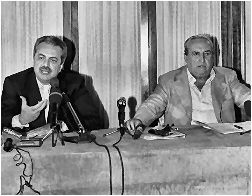 DE LAURENTIIS CAVALLO DI TROIA?
- Uomo dalla vista lunga, l’ultima volta che Roberto
Fiore si mise in luce fu quando sponsorizzò l’ingresso
di Aurelio De Laurentiis nel Napoli di Ferlaino.
L’ingegnere cercava con discrezione acquirenti e Fiore
gli portò su un piatto d’argento l’offerta del
produttore cinematografico. Il 5 luglio del 1999, De
Laurentiis, al fianco di Fiore, presentò la sua
proposta di acquisto. In pratica, non intendendo trattare
con Ferlaino, De Laurentiis voleva che Ferlaino mettesse
il titolo a disposizione della Federcalcio e poi lui, a
sua volta, lo avrebbe acquistato dalla FIGC per 50
miliardi. Per questa operazione De Laurentiis aveva
costituito la Società " Auro Calcio 2000" e si era
garantito una copertura bancaria per 100 miliardi,
quindi anche i soldi per una buona campagna acquisti. Ma la
conferenza di De Laurentiis, organizzata al Circolo della Stampa,
con le relative proposte (e molte freddezze), non ebbe un
seguito. Ferlaino non esaminò nemmeno il progetto.
Non ci fu replica da parte del presidente azzurro. Ai più (e a Ferlaino
soprattutto) era sembrato che De Laurentiis, “sprovveduto” sul
piano calcistico, fosse il “cavallo di Troia” per far
rientrare sottilmente Fiore nella Società. O forse più
semplicemente l'offerta non era sembrata degna
d'attenzione all'ingegnere. Ferlaino nell'aprile
dell'anno successivo vendette il 50% della Società a
Corbelli. Questi coprì
con 100 miliardi le esposizioni di Ferlaino verso le banche. Il nuovo arrivato acquisì
in comproprietà anche un suolo a Giugliano e le quote di maggioranza
di palazzo D'Avalos. Ma la
storia del Napoli cambiò egualmente qualche anno dopo. (Nella
foto, Aurelio De Laurentiis con Roberto Fiore al Circolo
della Stampa nel 1999) DE LAURENTIIS CAVALLO DI TROIA?
- Uomo dalla vista lunga, l’ultima volta che Roberto
Fiore si mise in luce fu quando sponsorizzò l’ingresso
di Aurelio De Laurentiis nel Napoli di Ferlaino.
L’ingegnere cercava con discrezione acquirenti e Fiore
gli portò su un piatto d’argento l’offerta del
produttore cinematografico. Il 5 luglio del 1999, De
Laurentiis, al fianco di Fiore, presentò la sua
proposta di acquisto. In pratica, non intendendo trattare
con Ferlaino, De Laurentiis voleva che Ferlaino mettesse
il titolo a disposizione della Federcalcio e poi lui, a
sua volta, lo avrebbe acquistato dalla FIGC per 50
miliardi. Per questa operazione De Laurentiis aveva
costituito la Società " Auro Calcio 2000" e si era
garantito una copertura bancaria per 100 miliardi,
quindi anche i soldi per una buona campagna acquisti. Ma la
conferenza di De Laurentiis, organizzata al Circolo della Stampa,
con le relative proposte (e molte freddezze), non ebbe un
seguito. Ferlaino non esaminò nemmeno il progetto.
Non ci fu replica da parte del presidente azzurro. Ai più (e a Ferlaino
soprattutto) era sembrato che De Laurentiis, “sprovveduto” sul
piano calcistico, fosse il “cavallo di Troia” per far
rientrare sottilmente Fiore nella Società. O forse più
semplicemente l'offerta non era sembrata degna
d'attenzione all'ingegnere. Ferlaino nell'aprile
dell'anno successivo vendette il 50% della Società a
Corbelli. Questi coprì
con 100 miliardi le esposizioni di Ferlaino verso le banche. Il nuovo arrivato acquisì
in comproprietà anche un suolo a Giugliano e le quote di maggioranza
di palazzo D'Avalos. Ma la
storia del Napoli cambiò egualmente qualche anno dopo. (Nella
foto, Aurelio De Laurentiis con Roberto Fiore al Circolo
della Stampa nel 1999)
Gigino Scuotto, il Richelieu azzurro
di Giuseppe Pacileo
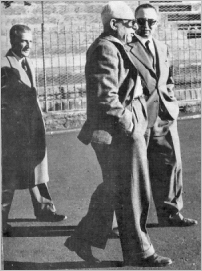 Negli
annali non figura tra i presidenti del Napoli. Era
allergico alla carica, la ricoprì nel 1945 solo per un
mese, in maniera diciamo così tecnica, per la
rifondazione dell’Associazione Sportiva Napoli , poi
tornò dietro le quinte. Dietro quelle quinte da cui per
decenni orientò, raddrizzò, salvò le sorti del Napoli.
Tra le sue diaboliche trame, moltissime e non tutte
“raccontabili” anche se prescritte nel tempo, i due
grandi capolavori di Gigino Scuotto furono quelli
organizzati e portati felicemente a termine nel 1962 per
un tentativo di corruzione e l’anno dopo per un caso di
doping. Nella prima vicenda, Scuotto riuscì a
smantellare tutte le prove che erano state raccolte
contro il Napoli per un “presunto” tentativo di comprare
a Verona la gara della promozione in Serie A (dicono
manipolando nastri magnetici e svalutando un superteste
che d’incanto avevano perso voce, chiarezza e memoria).
Negli
annali non figura tra i presidenti del Napoli. Era
allergico alla carica, la ricoprì nel 1945 solo per un
mese, in maniera diciamo così tecnica, per la
rifondazione dell’Associazione Sportiva Napoli , poi
tornò dietro le quinte. Dietro quelle quinte da cui per
decenni orientò, raddrizzò, salvò le sorti del Napoli.
Tra le sue diaboliche trame, moltissime e non tutte
“raccontabili” anche se prescritte nel tempo, i due
grandi capolavori di Gigino Scuotto furono quelli
organizzati e portati felicemente a termine nel 1962 per
un tentativo di corruzione e l’anno dopo per un caso di
doping. Nella prima vicenda, Scuotto riuscì a
smantellare tutte le prove che erano state raccolte
contro il Napoli per un “presunto” tentativo di comprare
a Verona la gara della promozione in Serie A (dicono
manipolando nastri magnetici e svalutando un superteste
che d’incanto avevano perso voce, chiarezza e memoria).
Nel secondo caso, dopo una vittoria del Napoli, a San
Siro per 1-0 sul Milan, gol di Corelli, il Napoli si
giovò di una sentenza più mite in un processo per uso
di doping contro alcuni giocatori azzurri. Prima (dopo
un allarme lanciato da Beato) furono
organizzati negli spogliatoi travasi d’urina “pulita”,
mentre tre altri contenitori diedero agli esami di
laboratorio risultati impensabili. Gli è che la “mano”
di Scuotto si intuì in quanto durante il trasporto delle
provette in laboratorio in taxi si era fatta una sosta
per prendere un caffè e la borsa con i liquidi era
rimasta in auto. Chissà forse il caldo... Certo è che al
momento delle analisi sembravano liquidi organici di
animali provenienti da un altro mondo! E nelle sentenze
ci scappò un compromesso, con la condanna di solo quattro
azzurri ad un mese di sospensione. Scuotto aveva salvato
il salvabile.
Ed ora dilunghiamoci un tantino sul personaggio. Merita
adeguato spazio nella lunga vicenda del Napoli: oltre
vent’anni di presenza ed incidenza, ma quasi sempre
dietro le quinte. Una sola volta si arrischiò a lungo
nel cono di luce del proscenio e ne rimase distrutto,
definitivamente.
Vent’anni: da quel primo di giugno 1944 allorchè fece parte
del gruppetto che fondò la Società Polisportiva Napoli
fino al ’64, giugno egualmente, quando dov’è lasciare il
passo a Roberto Fiore, dopo quasi un anno di zoppicante
“reggenza”. Presidente no, soffriva d’allergia per
quella definizione. Presidente – come abbiamo detto - fu
soltanto una volta, dal 19 gennaio ’45 sino al 21 di
febbraio successivo, dell’Associazione Sportiva Napoli,
nata dalla fusione tra la predetta Società Polisportiva
e la Società Sportiva Napoli (il bizantinismo
degl’individualismi napoletani…). Vicepresidente,
invece, passi. Reggente con Cuomo per breve periodo nel
1951. Membro della Giunta a sei inventata da Lauro due
anni dopo. Fu lui, Scuotto, che don Achille propose come
“assistente psicologico” per domare una rivolta di
Monzeglio (che odiava Scuotto d’un sentimento viscerale:
qualcosa come Bearzot contro Allodi…); fu lui che
accompagnò Pesaola alla firma per l’esordio quale
allenatore del Napoli. E chissà quante campagne-acquisti
condusse oppure orientò, chissà quante paroline decisive
sussurrò dalla penombra al momento giusto.
Esperto come pochi – a Napoli unico – di regolamenti e
relative tecniche per aggirarli, molti servigi rese al
Napoli; ma quasi sempre di quelli che non consentono di
vantarsene. Dunque, paragonabile agli “eroi” sconosciuti
che – su ben altra dimensione - orientano i destini del
mondo (CIA,KGB, Deuxième Bureau e così recitando).
Dunque, un “eroe” in negativo; meglio, forse: la
negativa del ritratto d’un “eroe”; che venisse stampata,
quella foto, non volle lui, pur possedendo notevolissime
doti dirigenziali. Ma, innanzitutto, non possedeva tutti
i quattrini che gli sarebbero occorsi, e tanto meno la
voglia di rimetterci.
Trovò modo di usare quelli ‘d’altri, ben conscio del
celebre detto. “Les affaires? Mais c’est simple! Ce sont
l’argent des autres” Gli affari? Facile: sono il denaro
altrui.
Sapeva aspettare. Al sopraggiunger delle emergenze, o lo
chiamavano, oppure egli stesso con tempismo notevole,
s’infilava nel girotondo. Lauro lo rispettava, un po’ lo
temeva, nel complesso lo trovava riposante e utile,
sempre disposto all’accomodamento. Due attività aveva
coltivato in gioventù: la scherma (e gli capitò di
affrontare in duello Silvio Gava, l’emigrato veneto
superpotenza politica in Castellammare, poi ben oltre) e
l’arbitraggio. Facile chiave di lettura: esperto
nell’arte delle attese, delle finte, de’ tempestivi
affondi e, insieme, naturalmente portato ad arbitrare,
dunque a valutare, dirimere controversie, decidere ne’
tempi dovuti. In breve: eminenza grigia per costituzione
mentale, puntava diritto al sodo: non pronunciare
brindisi al banchetto ma piuttosto di quei banchetti
esser l’organizzatore e possibilmente il fornitore.
Eminenza grigia, però direi di più di un Richelieu.
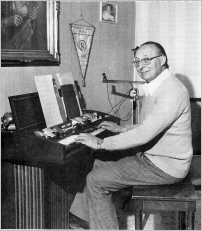 Al
Napoli del dopoguerra, intanto, procurò due campi di
giuoco: quello provvisorio dell’Orto Botanico, l’altro –
per ben più lunga pezza – al Vomero (con annessa sede).
Di quegli anni narrerò due vicende relative al Nostro.
All’Orto Botanico – era l’immediato dopoguerra –
s’acconciarono ad organizzare una riunione di pugilato
lui, Ernesto Centobelli, Enrico Marcucci e qualche
altro. Incontro di cartello, fra un negrone
dell’esercito americano e Michelone Palermo, idolo
locale. Le sedie vennero prese in prestito da una vicina
parrocchia, tutto pareva pronto; ma all’ultimo momento
si volatilizzò ‘o niro. Al
Napoli del dopoguerra, intanto, procurò due campi di
giuoco: quello provvisorio dell’Orto Botanico, l’altro –
per ben più lunga pezza – al Vomero (con annessa sede).
Di quegli anni narrerò due vicende relative al Nostro.
All’Orto Botanico – era l’immediato dopoguerra –
s’acconciarono ad organizzare una riunione di pugilato
lui, Ernesto Centobelli, Enrico Marcucci e qualche
altro. Incontro di cartello, fra un negrone
dell’esercito americano e Michelone Palermo, idolo
locale. Le sedie vennero prese in prestito da una vicina
parrocchia, tutto pareva pronto; ma all’ultimo momento
si volatilizzò ‘o niro.
Il pubblico attendeva entusiasta, impaziente…E che si
fa? Fulminea la decisione: acchiappano un altro negro,
gli spiegano a segni come stanno più o meno le cose, gli
ficcano in mano un pacchetto di AM-lire. Quello si
prepara. Forse ancor più difficile spiegarsi con
Michelone: “Vacci piano, è un avversario rimediato, tira
l’incontro per le lunghe, difenditi. Poi verso la
sesta-settima ripresa lo stendi. Chiaro ?” Michele
Palermo
annuì. All’inizio il nero appariva piuttosto timoroso,
poi s’accorse che l’italiano non picchiava; prese
lucciole per lanterne. Tutto ringalluzzito, cominciò a
darci dentro lui, e tanto bene ci riuscì che – a un
certo punto, troppo presto! - Michelone perse lo ben
dell’intelletto e con un solo sganassone polverizzò quel
presuntuoso. Catastrofe! Pubblico inferocito, si salvi
chi può. Nell’ammoina generale due esseri disperati: un
parroco che vede andare in frantumi le seggiole della
sua chiesa ed un sedicente pugile di pelle nera che
lancia urli forsennati perché, e ti pareva?, nella calca
gli avevano sfilato il rotolo di AM-lire dal taschino
posteriori dei calzoncini. Fin qui la variazione
pugilistica. Per tornare al calcio spostiamoci avanti
nel tempo, fino a giugno del ’51 e nello spazio fino
allo stadio “Appiani” di Padova.
Si concludeva il primo campionato del Napoli dopo il
ritorno in Serie A. Buona la classifica, non
migliorabile. Torna in campo Gegio Gaggiotti gran
manovratore di risultati – certe cose nel calcio sono
accadute sempre – che pur col Napoli aveva “fatto
affari”. Scuotto lo chiamava ‘o bbandito… Quel tale si
vantava d’aver “combinato” intorno alle seicento partite
e proprio nel Napoli era riuscito a piazzare un fratello
calciatore. Quel giorno il Gaggiotti…a bulloni giocò due
partite; una appunto a Padova. Però – relata refero – fu
all’azzurro Bruno Gramaglia che qualcuno (…) soffiò in
un orecchio che gli conveniva comportarsi rudemente in
area di rigore; e Gramaglia capì (sembra che il Padova
avesse promesso a Scuotto di favorire, in caso di
vittoria dei locali la cessione in azzurro di un
giocatore già prescelto) . Però tra i pali napoletani
campeggiava una specie di Michelone Palermo della
pelota, il gigantesco Casari. Due rigori, due paratone.
Evidentemente non avevano informato anche lui... Ci volle la mano di Dio perché Martegani riuscisse a
piazzare in rete le due palle che salvarono il Padova e
condannarono alla B la Roma…. E quel giocatore gradito
dal Napoli naturalmente restò a Padova.
Così era don Gigino. Fatto sta che – Monzeglio escluso
– non v’era chi non lo trovasse simpatico. A cominciare
dal Comandante; il quale, chissà, manco s’accorse che
qualche volta Giggino “lo faceva fesso”. Basti pensare
che girava, in certe particolari occasioni, con due
telegrammi in tasca: a seconda di come finiva la
partita, tirava fuori l’uno oppure l’altro, per dare la
sua versione dell'andamento dei fatti, ritrovandosi
ovviamente sempre dalla parte della ragione. Se
andava contrariamente al promesso e previsto, già era
predisposta la spiegazione “dell’imprevisto all’ultimo
momento” Fatto sta che, dopo essersi tanto adoprato a
corbellare accusatori e giudici per aiutare il Napoli,
proprio Scuotto finì con l’affossarlo l’ennesima volta.
Nella stagione 1963-64 riuscì a “lavorarsi” Lauro per
acquisire i pieni poteri quale “reggente” , ma capì poi
col tempo che l’astuzia e l’esperienza non bastano per
guidare al successo le ambizioni calcistiche di una
grande città; che inoltre molto spesso ciò ch’è fatto è
reso. Lassù troneggiava, inespressivo, il nume Achille,
che non poco l’aveva deluso. Da giocatore accorto,
Scuotto, reggente povero – come amava definirsi - passò
la mano.
Peraltro va rilevato che con le sue manovre Scuotto
riuscì di fatto ad accelerare l’avvento di Fiore,grande
svolta nella tormentata vicenda del calcio a Napoli.
Egli sparì. Riebbe notorietà una decina d’anni dopo,
quasi settantenne (era nato il 5-3- 1905) in panni
d’autore di canzoni. Gli mancava soltanto di cantarle
per poter dire alla maniera di Armando Gill: parole di
Scuotto, musica di Gigino, cantata da Gigino Scuotto.
Nel Napoli, per tante cantate, era invece andata proprio
così.
Giuseppe Pacileo
Nelle foto, in alto a sinistra, Gigino Scuotto con
Achille Lauro e Paolo Innocenti allo Stadio del Vomero;
al centro a destra, Scuotto,
compositore di canzoni, al piano.
Napoli, il Napoli, lo scudetto e l'ingegnere
di Gino Palumbo
Napoli, il Napoli e il suo primo scudetto. Ecco
le impressioni sullo scudetto dettate da Gino Palumbo, grande,
indimenticato giornalista napoletano. Gino Palumbo, già Capo del
Servizi Sportivi de Il Mattino, e Direttore di SportSud
negli Anni 50, poi a Milano responsabile dello sport del
Corriere della Sera, quindi direttore del Corriere
d’Informazione e infine, per sette anni, Direttore della
Gazzetta dello Sport, scomparso, a 66 anni, nel
settembre del 1987, dopo aver rinunciato per motivi di
salute alla prestigiosa direzione del Corriere della
Sera. Le impressioni sullo storico evento calcistico
partenopeo sono state raccolte
nell’intervista-testimonianza rilasciata da Gino Palumbo
a Enrico Parodi , autore di un libro sulla vita del
famoso giornalista.

Seconda
domenica di maggio dell’ottantasette. Napoli conquista
per la prima volta lo scudetto, si colma un vuoto
assurdo: la città ha sempre donato al calcio miliardi e
passioni. Gli ingredienti per il successo esistono da
decenni, ma prevaleva sempre un male antico:
l’improvvisazione. Così le continue sconfitte si sono
trasformate in angoscia, quasi fossero prove
d’incapacità collettiva, segno d’inferiorità
irreversibile. Lo scudetto è diventato realtà
aggiungendo efficienza milanese all’estro, al cuore, al
calore napoletani. E ora quegli attimi di baldoria
dicono: anche noi siamo capaci. Prima del trionfo i
tifosi si tenevano per mano, quasi senza parlare:
tacevano la parola scudetto, ma ammiccavano dandosi di
gomito. Una “sceneggiata del silenzio” di ispirazione
teatrale: scaramanzia, orgoglio, consapevolezza di
essere vicini a un traguardo storico. E il Nord si
intenerisce, esprime ammirazione, simpatia.
Poi, dopo sessant’anni, lo scudetto. Un successo arrivato
prima sarebbe stato immeritato, casuale, sporadico. Ora
è frutto di un lavoro caparbio. Il Napoli ha costruito
un’intelaiatura solida: è il capolavoro del presidente
Corrado Ferlaino, questo trionfo porta la sua firma.
L’impegno dell’allenatore, le qualità dei giocatori non
bastano in un ambiente difficile qual è quello
napoletano. Se la società non avesse funzionato, tutto
sarebbe crollato a metà torneo: come tante volte è
accaduto in passato. L’atteggiamento responsabile e
rigoroso di Ferlaino contagia anche i tifosi, fanno
festa senza invadere il terreno del San Paolo. E’
dimostrato: una società seria genera pubblici maturi.
Maradona. Lui incanta gli avversari con magiche
invenzioni, la sua smania di vincere contagia la
squadra. La città lo idolatra, lo trattano da figlio. Ma
lui esige il monopolio sulla sua vita privata. Invece è
personaggio pubblico: in campo e fuori. Deve fare
attenzione: non può permettersi certe insofferenze.
 Questo
scudetto, comunque, non cancella le miserie, né attenua
le amarezze; i problemi rimangono: ma il calcio dimostra
che è possibile risolverli, organizzandosi. E quell’entusiasmo
può diventare spinta galvanizzante verso aspirazioni più
elevate. Poi lo scudetto prova che il vittimismo è
ingiustificato: smaschera i napoletani che non assumono
iniziative, rifiutano le responsabilità e aspettano la
manna dal cielo. Ovunque senti ripetere “Ma chi te lo fa
fare? Qua non si può fare niente!” E incolpano gli
altri, lo Stato. Quell’atteggiamento nasce dalla cultura
araba e dalle dominazioni spagnole: è la più grave
malattia di Napoli. Anche qui si può, invece, lavorare
bene: certo serve più tenacia, forza di volontà. Napoli
non aiuta chi si industria. E se qualcuno vuole
andarsene, prima lo agevolano, poi lo colpevolizzano. Questo
scudetto, comunque, non cancella le miserie, né attenua
le amarezze; i problemi rimangono: ma il calcio dimostra
che è possibile risolverli, organizzandosi. E quell’entusiasmo
può diventare spinta galvanizzante verso aspirazioni più
elevate. Poi lo scudetto prova che il vittimismo è
ingiustificato: smaschera i napoletani che non assumono
iniziative, rifiutano le responsabilità e aspettano la
manna dal cielo. Ovunque senti ripetere “Ma chi te lo fa
fare? Qua non si può fare niente!” E incolpano gli
altri, lo Stato. Quell’atteggiamento nasce dalla cultura
araba e dalle dominazioni spagnole: è la più grave
malattia di Napoli. Anche qui si può, invece, lavorare
bene: certo serve più tenacia, forza di volontà. Napoli
non aiuta chi si industria. E se qualcuno vuole
andarsene, prima lo agevolano, poi lo colpevolizzano.
Milano è competizione, emulazione. Di fronte a chi ha
successo, pensano: se lavoro e mi impegno come lui,
riuscirò anche io. Invece a Napoli dicono: ma come avrà
fatto? Avrà rubato qua, avrà rubato là; forse la sorella
è amica del presidente del Banco. Insomma, cercano mille
pretesti. Intanto cercano di spingere giù quel poveretto
che è “riuscito”, non per rubargli il posto, ma per
ribadire che qui nulla si può fare. La carriera degli
altri non fa da pungolo, diventa specchio per le proprie
pigrizie e va spezzato. Napoli è un’adorabile città, fa
struggere di nostalgia, ma è spietata con chi,
napoletano, cerca di servirla con un lavoro serio.
Scatta un inconscio meccanismo di gelosia: e si placa
soltanto quando l’ “intraprendente”, deluso e
amareggiato, si arrende e rientra nei ranghi degli
scettici, Ma se Napoli morirà non morirà sola:
trascinerà con sé tutto il Paese; servono interventi
d’alta chirurgia, non impacchi con semi di lino.
Gino Palumbo
Nelle foto: in alto, lo striscione di successo "Scusate
il ritardo", ispirato al film di Troise, durante i
festeggiamenti per il primo scudetto; in basso Gino
Palumbo al matrimonio di Louis Vinicio.
Un
raptus nordista contro i due miliardi per
Beppe-gol
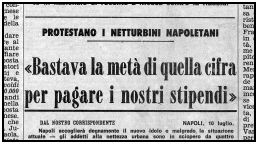
L’acquisto
di Savoldi, valutato tra contanti e cambio-giocatori due
miliardi, suscitò nel 1975 un vespaio di polemiche, come
quelle che si addensarono su Napoli in occasione degli
altri tre “grandi colpi” realizzati dalla società
azzurra nella sua storia: l’acquisto di Colombari nel
1930 , per 250 mila lire, quello di Jeppson nel 1950,
per 105 milioni, e infine quello dell’impareggiabile Maradona nel 1984, per 13 miliardi. L’ingaggio di
Beppe-gol mise letteralmente a soqquadro il mondo del
calcio, provocando reazioni contraddittorie anche da
parte di chi , come la Juve, il Milan e la Roma, fino
all’ultimo avevano lusingato il Bologna per poter
acquistare il bomber e che poi si unirono al coro di
quanti restarono scandalizzati per la valutazione data
al giocatore. Soprattutto al Nord vennero rispolverati i
vecchi, irrisolti problemi di Napoli, i suoi guai, le
sue miserie. Addirittura fu dato ampio risalto al
deficit comunale, sottolineando (assurdamente) che con
quei soldi si potevano pagare gli stipendi dei
netturbini in sciopero (nella foto il ritaglio di un
quotidiano). Un giornale milanese uscì addirittura con
la “foto della monnezza” sotto il titolo a tutta pagina
dei due miliardi, quasi a voler significare che il
Napoli avrebbe dovuto sostituirsi alle autorità ,
stipendiando netturbini privati. Fu “un raptus
sarchiaponico moraleggiante che percorse l’Italia da
Roma in su” come scrisse opportunamente Giuseppe Pacileo
su “Il Mattino”, in polemica soprattutto con la desolata
“Gazzetta dello Sport” che guidò la crociata di denuncia
per lo “sperpero” napoletano, ignorando, invece, i
precedenti e recenti acquisti-record di Sormani (Roma),
Anastasi e Tardelli (Juve) Speggiorin (Fiorentina), e
soprattutto trascurando che Agnelli era disposto a
sborsare per Savoldi qualche anno prima la stessa cifra
impiegata dal Napoli.
Si parlò di “schiaffo alla miseria”, ignorando che “la plebe
napoletana”, come chiamarono i giornali del nord
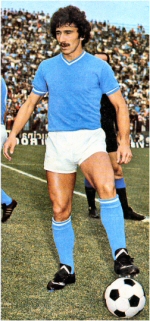 i
tifosi azzurri, era rimasta tutt’altro che indignata e
in fin dei conti si pagava in proprio i suoi “sollazzi
calcistici”, con i biglietti e gli abbonamenti. La
verità era che il Napoli stava per diventare un brutto
spauracchio per le “grandi” e che il colpo aveva dato
fastidio soprattutto in chiave di concorrenza. i
tifosi azzurri, era rimasta tutt’altro che indignata e
in fin dei conti si pagava in proprio i suoi “sollazzi
calcistici”, con i biglietti e gli abbonamenti. La
verità era che il Napoli stava per diventare un brutto
spauracchio per le “grandi” e che il colpo aveva dato
fastidio soprattutto in chiave di concorrenza.
A tal proposito ci piace riprodurre l’articolo magistrale e
controcorrente scritto in quei giorni da Enzo Biagi sul
“Corriere della Sera”, con una convinta difesa
dell’acquisto del Napoli, in risposta alla inopportuna
crociata di chi, scandalizzato, stava cavalcando la
questione della miseria e della disoccupazione, che pur
assillavano la città.
Savoldi come San Gennaro
di Enzo Biagi
Non conosco
l’ingegnere Corrado Ferlaino, ma deve essere un
personaggio notevole. In un posto come Napoli è riuscito
a mettere in piedi una forte squadra di calcio. Può
comperare un centrattacco pagandolo due miliardi, e
niente cambiali, contanti. Non capisco perché non lo
abbiano fatto sindaco o mandato a Montecitorio. In una
città che abbia per simboli l’Alfa Sud, dove si lavora
un giorno su due, il vibrione, che è in agguato tutto
l’anno, e la raccomandazione, che dà diritto a diventare
spazzino e a non raccogliere le immondizie, ecco un uomo
capace, moderno, che conosce la psicologia delle folle,
le regole del bilancio e le astuzie della
contrattazione.
La sua ultima, leggendaria e meritoria impresa,
l’acquisto del “cannoniere” Giuseppe Savoldi, ha
suscitato lo sdegno nazionale: attacchi da ogni parte,
sinistra e destra, perché l’ipocrisia e la stupidità non
hanno tessera.
Secondo la stampa degli extraparlamentari, l’affare avrebbe
scandalizzato, prima di tutti, “le masse povere”. Ora
sono proprio questi diseredati che gremiscono lo stadio,
e affrontano una ritenuta sulla busta-paga per avere i
vantaggi dell’abbonamento. E’ il proletario che ha
bisogno di prodigi. San Gennaro, Piedigrotta, e i gol
della domenica, e non mi pare poi una grave colpa.
Perché a gente che ha così poco volete togliere anche la
partita? Perché, almeno in materia di calcio, non devono
sentirsi cittadini di Serie A? E cos’è questa storia
degli “schiavi d’oro” sottoposti a un volgare peccato?
Forse che un metalmeccanico, disdegnerebbe, in caso di
trasferimento, un cospicuo premio di ingaggio?
E questi moralisti hanno mai sentito parlare, per esempio, di
Lev Ivanovic Iascin, detto “il ragno nero”, il grande
portiere sovietico, che andava in giro, tra un popolo di
appiedati, su una lucente Volga azzurra, e adesso
possiede, nientemeno, un appartamento di tre camere e
ingresso?
Le gambe anche all’Est, hanno sempre avuto il loro peso, si tratti
di quelle della danzatrice Plisetskaia , o del
calciatore Puskas: se un attaccante segnava spesso,
poteva anche diventare colonnello, e in eserciti dove le
riforme non fanno ridere.
Laggiù la sveglia, al mattino, non è un garbato invito a prendere
atto che è spuntata l’alba, ma l’ordine di mollare la
branda, ufficiali e soldati si danno del tu, ma il
compagno capitano manda con cameratesco slancio il
compagno fante a pulire le latrine, e i militari che
vanno in licenza e che incontri alla stazione sono in
divisa, perché non si vede come possa essere un onore
indossarla per la strada e uno scomodità portarla in
treno.
E poi, è più vergognoso ingaggiare una mezz’ala, un terzino o un
deputato? Trattare all’Hilton o nelle segreterie dei
partiti? Di che cosa dovrebbe stupirsi un Paese che ha
aperto, più o meno formalmente, quattro o cinque
inchieste parlamentari, e sempre per questioni di
quattrini, e tiene sospesi tre o quattro drammatici
processi, e sempre per ragioni legate alla politica?
E le obiezioni di destra, dove le mettiamo? Che ridere. Sì,
l’accusa di spendere tanti soldi dietro a un pallone.
Prima di tutto si tratta di uno scambio di carta tra
privati, alla quale si dà, più che altro, un valore
convenzionale, una specie di baratto, come quelli che
intrecciava Cristoforo Colombo con i pellerossa: io ti
do tre specchietti e sei perline e tu mi dai un po’ di
quel metallo che brilla, dalle mie parti lo chiamano
oro. Io ti do un’ala tornante e tu un libero e un
mediano di spinta.
Accade in tutto il mondo che i ragazzi che sanno lanciare bene la
sfera di cuoio facciano carriera. In America gli
dedicano anche monumenti. Nelle patrie del socialismo
sono esonerati dallo stare alle catene di montaggio
delle varie Dinamo o Lokomotiv, purchè seguano con
diligenza e passione i consigli degli allenatori e le
invocazioni dei tifosi.
Da noi ogni anno scatta lo sdegno a comando per le follie del
football, e con scadenza stagionale, la predica inizia
coi primi seminaristi che annegano prendendo il bagno
nel lago, con le fotografie di colonne di auto ferme
sull’autostrada e con le cupe previsioni sul prossimo
autunno caldo e l’inesorabile inverno freddo.
Questa volta c’è stata anche la cifra che ha incoraggiato le
chiacchiere, perché considerata esorbitante, ma non
hanno tenuto conto della discesa della lira, e poi la
destinazione del campione; se andava alla Juventus tutto
bene, nessuno avrebbe parlato di cassa integrazione,
delle coree e dei problemi degli immigrati.
L’ingegnere Ferlaino non è né un dissipatore né un Pulcinella: è un
freddo manager che si adegua alla realtà. Fa il suo
mestiere molto bene. Non tocca a lui risolvere le
secolari questioni sociali, realizzare le riforme e la
giustizia: spaghetti, casa, un moderato lavoro, ma il
suo compito è organizzare la migliore formazione degli
“azzurri”. Non ha offeso la miseria, caso mai l’ha
consolata.
E poi, siamo onesti: Napoli non va male perché hanno comperato
Savoldi, ma perché non possono vendere i Gava.
Enzo Biagi |

